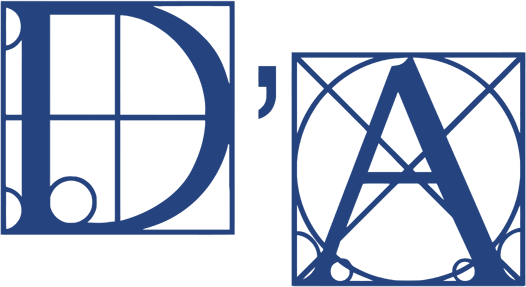
La fine ingloriosa della privatizzazione nei servizi pubblici
di Dario Messineo [*]
 Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 segna una svolta nel pubblico impiego sul piano della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro[1]. La cd “privatizzazione” doveva costituire un punto d’arrivo della disciplina pubblicistica, in tal modo la regolamentazione del rapporto di lavoro doveva escludere il potere unilaterale della legge a favore delle regole contrattuali, e conseguentemente privatizzare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare della dirigenza. Gli unici valori “pubblicistici” rimasti dovevano concretarsi nell’imparzialità e nell’indipendenza della funzione che potevano dar vita a codici di comportamento relativi all’etica del funzionario pubblico ed una separazione della politica dalla dirigenza pubblica. La scelta della contrattualizzazione era stata adottata per evitare l’emanazione di farragginose leggi o leggine che potessero creare disparità di trattamento tra pezzi dello stato e permettere un rapido adeguamento flessibile e duttile al mutamento delle regole e ai cambiamenti sociali, secondo gli schemi tipici della disciplina privatistica.
Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 segna una svolta nel pubblico impiego sul piano della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro[1]. La cd “privatizzazione” doveva costituire un punto d’arrivo della disciplina pubblicistica, in tal modo la regolamentazione del rapporto di lavoro doveva escludere il potere unilaterale della legge a favore delle regole contrattuali, e conseguentemente privatizzare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare della dirigenza. Gli unici valori “pubblicistici” rimasti dovevano concretarsi nell’imparzialità e nell’indipendenza della funzione che potevano dar vita a codici di comportamento relativi all’etica del funzionario pubblico ed una separazione della politica dalla dirigenza pubblica. La scelta della contrattualizzazione era stata adottata per evitare l’emanazione di farragginose leggi o leggine che potessero creare disparità di trattamento tra pezzi dello stato e permettere un rapido adeguamento flessibile e duttile al mutamento delle regole e ai cambiamenti sociali, secondo gli schemi tipici della disciplina privatistica.
La modifica al d.lgs. 165/2001, attuata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[2], doveva accentuare questo aspetto ma è andata nel senso esattamente opposto, restringendo i campi di applicazione contrattuale, senza però effettuare una scelta di campo ben precisa e netta. Anche la recentissima cd. Riforma Madia[3] non proponendo alcuna specifica innovazione su questo punto, (anzi al contrario puntando più che altro sulla disciplina pubblicistica) si limita ad intervenire su alcuni punti specifici, in nome della, ormai arci nota, spending review e della lotta agli sprechi e alla corruzione.
A questo punto la disciplina del lavoro pubblico non solo appare profondamente diversificata tra i vari comparti pubblici, ma rimane monca delle problematiche connesse al rapporto contrattuale che sarebbero affidate, in parte (e, ribadisco, solo in parte) ad una tornata contrattuale che non vede la luce da un decennio e che desta poco interesse alla politica ed all’opinione pubblica. La netta sensazione, allo stato attuale, è quella che l’avvicinamento che si vuole realizzare alla disciplina privatistica sia l’applicazione dei poteri datoriali tout court (quasi arbitrari), senza alcun riconoscimento delle tutele che vengono attribuite ai lavoratori dipendenti del privato. In questo senso vanno le previsioni di alcuni istituti, attribuiti, con riserva di legge, alla regolazione contrattata tra Aran e organizzazioni sindacali, che adesso devono trovare definizione esclusiva, in mancanza di espressa delega alla contrattazione, nella norma di legge statale[4].
Le considerazioni sopra riportate potrebbero far pensare che si tratti di casi isolati ma purtroppo non è così, tanto che ormai ad ogni cambiamento dei ministri che si occupano della funzione pubblica accade che viene aggiunto un tassello volto a eliminare, non le criticità presenti nelle organizzazioni pubbliche, ma a anestetizzare gli effetti perversi che queste criticità determinano, secondo gli orientamenti, volta per volta, dettati dalla pancia del corpo elettorale. Il pubblico impiego, in sostanza, è utilizzato come argomento per tenere buona l’opinione pubblica scaricando su di esso le ragioni delle disfunzioni o come vero e proprio bancomat del governo per tagliare rapidamente le spese pubbliche. In questo senso vanno le riforme sulle sanzioni disciplinari, che sostanzialmente sono uscite dall’ambito contrattuale, quella sulle visite mediche (che determinano un cambiamento completo dalla disciplina privatistica), quella sul sistema di rilevazione delle presenze (che sembra, in questo momento, costituire l’unico problema da risolvere per i dipendenti pubblici) quella sulla valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento economico accessorio, quella sulla mobilità del personale, quella sulle progressioni economiche, quella delle restrizioni alle deleghe sindacali e (quanto alla dirigenza) quella sul conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e sulla nuova dirigenza pubblica, ecc..
A ciò si aggiunga la volontà della politica di accaparrarsi di interi pezzi della pubblica amministrazione per piegarla ai propri bisogni, talvolta con lo scopo dell’efficientamento, talaltra (e più spesso) con lo scopo specifico di ridurre i compiti amministrativi a mera attività esecutiva a servizio del politico di turno, senza il rispetto delle più elementari regole di imparzialità e buon andamento che devono indirizzare la pubblica amministrazione.
Per fare un esempio concreto basti citare la nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di ben 1400 incarichi dirigenziali delle Agenzie fiscali[5], che erano avvenuti, attraverso regolamenti e leggi ad hoc di natura temporanea, in favore di persone, in alcuni casi, nemmeno in possesso della laurea, che non avevano sostenuto alcun concorso pubblico per esami. Stranamente in questa ipotesi non c’è stata alcuna indignazione pubblica né tantomeno alcuna conseguenza politica. Eppure la previsione della obbligatorietà del concorso pubblico per il raggiungimento degli incarichi dirigenziali, stabilita dall’art. 97 della costituzione, dovrebbe essere un valore acquisito dal nostro ordinamento, e costituire la regola cardine affinchè sprechi e inefficienze fossero banditi dalla normale routine quotidiana della burocrazia italiana. Ma evidentemente l’opinione pubblica non percepisce nettamente il rapporto diretto tra il rispetto delle regole e un’adeguata competenza e direzione dell’azione pubblica. A ciò si aggiunga che alla politica fa gola poter nominare vertici dirigenziali secondo le regole non scritte dell’appartenenza ad una determinata fazione o comunque ad una categoria di persone che non diano eccessivamente fastidio e non siano “troppo” competenti. Poi se i cosiddetti “nominati” operano senza conoscere le norme di legge, calpestando i lavoratori, o peggio, fornendo servizi con pessimi standard qualitativi di efficienza e professionalità, poco importa; tanto nel caso di carenza di controlli adeguati o scelte sbagliate dovute a palese incapacità manageriale basterà varare l’ennesima norma “finta” sulla trasparenza o sui cartellini o attribuire la responsabilità al classico “capro espiatorio” da dare in pasto all’opinione pubblica e tutto sarà risolto!
Prevale, quindi, la confusione ed in quest’ambito la cosiddetta area grigia, che sta a metà tra la zona bianca della legalità e nera dell’illegalità, in cui non c’è ordine tra legale ed illegale, in cui sussistono rapporti di scambio estremamente vantaggiosi per gli attori esterni ed interni che assume dei confini incerti. Secondo uno studio sociologico che ha analizzato i fenomeni sociali italiani si può parlare di “un processo di reciproco riconoscimento, in base al quale si scambiano beni e servizi, si avvalgono gli uni delle risorse e delle competenze degli altri, si sostengono per conseguire specifici obiettivi ed in alcuni casi costituiscono alleanze organiche per tutelare o perseguire interessi comuni. In questo modo, tendono a instaurarsi giochi a somma positiva”, cioè con un vantaggio per tutti i partecipanti[6].
In questo stato che possiamo definire di “confusione istituzionale e politica”[7] la prassi che si è osservata in questi anni, tra l’altro, è quella per la quale l’ARAN, con la complicità delle OO.SS. silenti, redige pareri nell’ambito del pubblico impiego che alla fine diventano vere e proprie norme di legge e la funzione pubblica emette note esplicative, che nulla hanno a che vedere con la norma stessa ma che interpretano le norme in modo praeter legem (ed a volte, addirittura, anche contra legem) soprattutto laddove entrano in ballo diritti soggettivi dei lavoratori pubblici “privatizzati”, che sono ben diversi dai lavoratori privati, in tutti i sensi[8].
Di seguito cercheremo di analizzare soltanto alcuni casi emblematici svolti a meglio specificare quanto sopra affermato.
 I “quadri” nel pubblico impiego
I “quadri” nel pubblico impiego
Un esempio emblematico, che qui si vuole richiamare, è quello dell’area intermedia dei “quadri” nel pubblico impiego ed in particolare, nel comparto stato, osteggiata a tutti i livelli con motivazioni, a dir poco, fantasiose.
La legge 13 maggio1985 n. 190, applicabile ai lavoratori pubblici e privati, diede una definizione generica della categoria dei “quadri”[9], affidando alla contrattazione collettiva il compito di individuare i requisiti di appartenenza[10]. La previsione, occorre precisare, era già presente nell’art. 2095, 2° comma, c.c.. A fronte di una previsione codicistica generica dei “quadri” a fugare ogni dubbio intervenne l’art. 40 del d.lgs.165/2001, che demandò alla contrattazione collettiva di comparto la definizione di una disciplina distinta per le figure professionali che svolgevano compiti di direzione o che comportavano l’iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca[11].
A ciò si aggiunga l’introduzione della legge 15/7/2002 n.145 con la quale il legislatore previde la creazione della separata area della vicedirigenza[12], che doveva essere disciplinata dalla contrattazione collettiva, dando parziale soddisfazione all’esigenza della creazione dell’area quadri nell’ambito del pubblico impiego statale e con lo scopo specifico di eliminare le differenze tra settore pubblico e privato. Le previsioni normative sopra descritte, dando ampio spazio alla contrattazione, di fatto, determinarono una distinzione netta tra i vari comparti pubblici, creando una situazione a “pelle di leopardo”. Mentre, di fatto, vennero istituite le “posizioni organizzative” negli enti locali e nel comparto Agenzie fiscali, invece nel parastato vennero riconosciuti i “professionals” e forti incentivi attribuiti alle posizioni di responsabilità. Viceversa nel Comparto Ministeri, si diede un forte impulso alle riqualificazioni, non ritenendo opportuno professionalizzare i lavoratori o responsabilizzarli attraverso l’istituzione delle cosiddette “posizioni organizzative” o introducendo le cosiddette “aree dei professionisti”. Ciò ha determinato, in quest’ultimo comparto, come effetto, per molti, ma non per tutti, un incremento economico di modestissimo rilievo[13], (a seguito del passaggio di categoria all’interno dell’area dal basso verso l’alto) senza peraltro alcun riconoscimento di uno specifico ruolo nell’organizzazione, ma ha causato, un conseguenziale, e poco proficuo, “generale appiattimento” verso il basso ingenerando, di fatto, confusione di ruoli e competenze professionali.
Fatte queste premesse occorre precisare che l’ARAN, interpretando autenticamente l’art. 13 del CCNL comparto Ministeri il 16.02.1999, dichiarava, sul tema, che l’Area dei “quadri” non era necessario costituirla espressamente nel pubblico impiego[14], in virtù della disciplina speciale prevista dai contratti pubblici (area della vice-dirigenza, posizioni organizzative e area dei professionisti) per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportino iscrizione ad albi oppure tecnico- scientifici e di ricerca.
Occorre, altresì, precisare che anche la giurisprudenza italiana[15], seguì l’orientamento ARAN sopra enunciato, inneggiando all’autonomia del sistema di classificazione del settore pubblico rispetto a quello privato, solo per la presenza di sistemi alternativi di riconoscimento della professionalità, che fondamentalmente sono i seguenti:
- l’area della vice-dirigenza;
- le posizioni organizzative;
- l’area dei professionisti.
Ebbene, allo stato attuale l’art. 40, 2 comma, così come richiamato dall’ARAN nella interpretazione autentica dell’art. 13 del CCNL è stato abrogato. Allo stesso modo è stata abrogata l’area separata della vicedirigenza (art. 17 del d.lgs. 165/2001)[16]. Mentre le posizioni organizzative come abbiamo visto nel comparto ministeri non mai state attuate.
Dunque tutte le argomentazioni per le quali l’area dei quadri non si doveva istituire pertanto sono cadute e non sussistono più giustificazioni giuridicamente plausibili per la mancata attuazione nel pubblico impiego dell’area dei “quadri” così come prevista dall’art. 2095 c.c. e dalla legge 190/1985.
In conclusione, ad oggi, possiamo dire che siamo ritornati esattamente a venti anni or sono, nel senso che tutte le norme che venivano addotte pretestuosamente quali uniche giustificazioni alla mancata introduzione dell’area dei quadri sono state non solo disapplicate a adesso definitivamente abrogate da legislatore. Come in una sorta di “gioco dell’oca” ci si trova attualmente di nuovo all’“anno zero” e cioè di nuovo più o meno anche nel 1995. Anno nel quale però, si rammenta, la giurisprudenza parlava di contenuto indubbiamente precettivo sia dell’art. 2095 c.c. che della legge 190/1985 sia nel settore pubblico che in quello privato[17].
Nonostante però tale situazione si sia cristallizzata da più di una anno nulla è successo nel pubblico impiego (comparto Ministeri) e nulla probabilmente succederà, considerate le politiche gestionali attuali, poco interessate al merito e alla competenza, se non attraverso nuove sentenze dei giudici che dovranno, loro malgrado, ritornare a dire quanto già affermato tanto tempo fa. L’unico barlume di speranza risiede nel ravvedimento operoso e concreto delle parti sociali presenti al tavolo a seguito della recentissima riunificazione dei comparti contrattuali[18] e nella recondita speranza che la contrattazione, con un improvviso rigurgito delle coscienze, possa ripartire daccapo, secondo regole totalmente innovative e attente alla realtà lavorativa concreta.
 Occorre, sul punto, ribadire che la previsione di un’area intermedia, che ha il profumo di una rivendicazione sindacale nuda e pura, costituisce, invero, l’ossatura attraverso la quale “funziona” e si “organizza” la pubblica amministrazione. Cioè stabilire nell’ordinamento professionale della P.A: un sistema classificatorio che preveda la linea di comando intermedio che traduca gli indirizzi le assicuri il rispetto delle regole operative in maniera certa, in virtù delle conoscenze degli obiettivi e delle regole procedurali, dà la possibilità, a chi opera all’interno delle aree di avere contezza delle proprie azioni e degli obiettivi da perseguire. Allo stesso tempo coloro che vengono investiti formalmente di un ruolo all’interno della organizzazione datoriale (pubblica o privata che sia) sono utili allo sviluppo della stessa ed implementano l’autostima ed il senso di appartenenza dell’istituzione e del gruppo di lavoro cui appartengono. La mancata creazione delle posizioni organizzative e delle aree dei professionisti, e contestualmente l’abolizione dell’area separata della vicedirigenza, e dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001, (che dava origine legale ad un’area quadri) costituiscono “pietre miliari” emblematiche della scarsa conoscenza dei “gangli vitali” del sistema organizzativo del pubblico impiego e una delle cause del declino della organizzazione datoriale verso l’appiattimento delle funzioni e dei compiti. L’assenza completa di una linea intermedia di comando con grande carica motivazionale, che trasformi quotidianamente gli obiettivi dati in azioni concrete sul territorio giustifica un comportamento spesso e volentieri schizofrenico degli organi pubblici sul territorio che distorcono, consapevolmente o inconsapevolmente, le direttive fornite dal vertice. Le conseguenze di questa scellerata idea che il pubblico impiego non abbia bisogno di posizioni intermedie qualificate e professionalizzate, segnatamente nell’ambito del comparto ministeri, ha ingenerato, specificatamente nel comparto predetto, piano piano, un diffuso menefreghismo degli obiettivi dell’azione pubblica, una mancata partecipazione corale alle iniziative provenienti dal vertice, una diffidenza qualunquista a qualsiasi iniziativa politica di innovazione mirata ad implementare l’azione pubblica. Qualunque iniziativa di reingegnerizzazione dei processi produttivi, difatti, prescindendo dalla qualità o meno della stessa, viene considerata oramai volta ad alimentare spot elettorali e non tale da efficientare realmente l’organizzazione del lavoro.
Occorre, sul punto, ribadire che la previsione di un’area intermedia, che ha il profumo di una rivendicazione sindacale nuda e pura, costituisce, invero, l’ossatura attraverso la quale “funziona” e si “organizza” la pubblica amministrazione. Cioè stabilire nell’ordinamento professionale della P.A: un sistema classificatorio che preveda la linea di comando intermedio che traduca gli indirizzi le assicuri il rispetto delle regole operative in maniera certa, in virtù delle conoscenze degli obiettivi e delle regole procedurali, dà la possibilità, a chi opera all’interno delle aree di avere contezza delle proprie azioni e degli obiettivi da perseguire. Allo stesso tempo coloro che vengono investiti formalmente di un ruolo all’interno della organizzazione datoriale (pubblica o privata che sia) sono utili allo sviluppo della stessa ed implementano l’autostima ed il senso di appartenenza dell’istituzione e del gruppo di lavoro cui appartengono. La mancata creazione delle posizioni organizzative e delle aree dei professionisti, e contestualmente l’abolizione dell’area separata della vicedirigenza, e dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001, (che dava origine legale ad un’area quadri) costituiscono “pietre miliari” emblematiche della scarsa conoscenza dei “gangli vitali” del sistema organizzativo del pubblico impiego e una delle cause del declino della organizzazione datoriale verso l’appiattimento delle funzioni e dei compiti. L’assenza completa di una linea intermedia di comando con grande carica motivazionale, che trasformi quotidianamente gli obiettivi dati in azioni concrete sul territorio giustifica un comportamento spesso e volentieri schizofrenico degli organi pubblici sul territorio che distorcono, consapevolmente o inconsapevolmente, le direttive fornite dal vertice. Le conseguenze di questa scellerata idea che il pubblico impiego non abbia bisogno di posizioni intermedie qualificate e professionalizzate, segnatamente nell’ambito del comparto ministeri, ha ingenerato, specificatamente nel comparto predetto, piano piano, un diffuso menefreghismo degli obiettivi dell’azione pubblica, una mancata partecipazione corale alle iniziative provenienti dal vertice, una diffidenza qualunquista a qualsiasi iniziativa politica di innovazione mirata ad implementare l’azione pubblica. Qualunque iniziativa di reingegnerizzazione dei processi produttivi, difatti, prescindendo dalla qualità o meno della stessa, viene considerata oramai volta ad alimentare spot elettorali e non tale da efficientare realmente l’organizzazione del lavoro.
La mancata attribuzione del riconoscimento di ruoli di vertice intermedi ha determinato un disinteresse diffuso all’obiettivo, macro, della soddisfazione degli utenti, implementando, invece, l’obiettivo, micro, della assenza di responsabilità. Questo ragionamento ha creato divisione e scarsa collaborazione degli operatori, che poco hanno contribuito all’azione di rinnovamento e hanno determinato un’azione di disgregazione del lavoro di gruppo, della collaborazione e della reciproca attenzione. Tutte le norme introdotte sono state, difatti, viste come peggiorative e volte a deprivare i lavoratori dei diritti acquisiti, senza tener conto del contenuto delle iniziative volte, talvolta, ad implementare i servizi.
Quanto sopra ha appiattito completamente le professionalità intermedie deprofessionalizzando e disorientando i “quadri” ed i “professionals”, presenti, numerosi nelle fila dei lavoratori pubblici. I fattori determinanti di questo insuccesso sono stati lo scarso senso di appartenenza e la mancata immedesimazione dei funzionari pubblici all’amministrazione. A ciò si aggiunga il continuo ricorso degli enti pubblici a professionalità esterne (ad esempio nei processi formativi o negli incarichi dirigenziali, o nella attribuzione di consulenze) che ha delegittimato coloro i quali all’interno ritenevano, fondatamente o meno, di possedere le qualità adeguate a svolgere quelle determinate funzioni e quei determinati incarichi esternalizzati. La politica della “par condicio” nel senso però del “tutti uguali in senso formale” e delle riqualificazione a tutti i costi, è da ritenersi tutt’altro che vincente nella pubblica amministrazione, al contrario, demotiva il personale e porta tutti i lavoratori in una spirale di scarso rendimento creando sacche sempre più numerose di disinteresse e disinformazione. Dall’altra parte spesso i vertici dell’amministrazione e la politica non comprendendo le cause del malessere vedono i lavoratori, qualificati o meno, come “smaniosi” di raggiungere determinati obiettivi, essendo il centro lontano dalle esigenze reali delle classi intermedie e dalla necessità del riconoscimento del ruolo all’interno dell’organizzazione.
A questo punto le modifiche sostanziali dell’organizzazione del lavoro volte al raggiungimento del “benessere organizzativo” ed il riconoscimento dei diritti dei lavoratori pubblici passano in secondo piano venendo in evidenza una strategia puntuale volta a denigrare sistematicamente gli operatori del pubblico impiego in una spirale di delegittimazione senza fine (interna ed esterna) che porta a cattive prassi e pessimi servizi pubblici.
 Le regole privatistiche in un quadro di impiego privatizzato
Le regole privatistiche in un quadro di impiego privatizzato
Nel quadro della cosiddetta “par condicio” tra dipendenti pubblici e privati occorre affrontare ancora un’altra questione, che in questo momento risulta irrisolta, perché non soggetta ad alcuna attenzione delle parti sociali.
Se è vero, difatti, che la Comunità europea ha dettato delle regole comuni relative all’orario di lavoro per tutti i dipenditi pubblici e privati[19], occorre chiedersi come mai queste regole non vengono applicate proprio ai pubblici dipendenti.
Ebbene occorre, a ben vedere, fare una distinzione tra “enti pubblici locali” per i quali le indicazioni della funzione pubblica non sono cogenti e le regole, invece, stabilite per gli enti pubblici prettamente statali. Come noto, difatti, il Ministero del lavoro, d’intesa con la funzione pubblica , all’indomani della emanazione del d.lgs. 66 dell’8 aprile 2003, integrato e modificato dal decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004, emanò la circolare esplicativa n. 8/2005.
Come chiaramente indicato in circolare e ribadito dall’ARAN unilateralmente[20] in tema di fruizione delle ferie i termini indicati dal CCNL del 6/7/1995[21] devono ritenersi prevalenti rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e pertanto le stesse non sono da ritenersi fruibili nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione come per tutti gli altri lavoratori. Pertanto il dipendente non può chiedere lo spostamento fino al 18° messe successivo a quello di maturazione, né tale spostamento può essere autonomamente operato dal datore di lavoro come avviene nel rapporto di lavoro privato. Stesso ragionamento può farsi in relazione al diritto del lavoratore a fruire delle ferie per 15 giorni consecutivi nell’anno stesso di maturazione.
In conclusione la flessibilità contrattale ha portato gli enti Statali ad un mancato adeguamento della disciplina contrattuale in un arco di tempo di 13 anni, nell’applicazione di una normativa di circa 20 anni fa, (cioè siamo nuovamente al cosiddetto “Anno zero”) alla faccia del rinnovamento e della duttilità del contratto rispetto alla legge, creando, tra l’altro, pericolose disparità di trattamento non solo tra dipendenti pubblici e privati, ma anche tra dipendenti pubblici[22].
La paternità negata ai pubblici dipendenti
Non dissimile è il ragionamento relativo alle giornate di congedo concesso recentemente dalla legge ai lavoratori padri per i dipendenti pubblici e privati. Nello specifico la legge 28 giugno 2012 n. 92, allo scopo di favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’intero della coppia, ha previsto alcune modifiche alle norme sulla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e con la Direttiva 2010/18/EU. 2).
La legge suddetta, in particolare l'art. 4, comma 24, della legge n. 92 del 2012, , prevede per gli anni 2013-2015, l'obbligo (per un giorno) e la facoltà (per due giorni) per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
La normativa è stata estesa dall’art. 1, comma 205, della l. 28/12/2015, n.208, a tutto il 2016 ed il congedo obbligatorio è stato portato a due giorni, più un giorno di facoltativo. n tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
Ebbene, pur essendo la normativa rivolta a tutti i dipendenti, pubblici e privati, anche in tal caso, neanche a dirlo, è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica che, con parere del 20/02/2013 n. DFP 0008629 P-4.17.1.7.5., ha stabilito che la norma non si applica ai dipendenti degli enti pubblici statali[23]. In particolare fa specie il parere della funzione pubblica in quanto non dichiara espressamente che il diritto non sussiste (e non si vede come potrebbe farlo vista la chiara indicazione della legge, all’art. 1, comma 7) ma precisa che a seguito di un fantomatico combinato disposto, (art. 1, commi 7 ed 8 ) “la normativa non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma occorre una apposita normativa che individui gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Come è agevolmente desumibile dalla lettura dell’art. 1, commi 7 ed 8, la normativa non fa esplicito riferimento ad un obbligatorio atto normativo ma stabilisce che si può intervenire “anche mediante iniziative normative”. Ebbene è chiaro che in tali ipotesi lo strumento naturale da adottare era quello contrattuale, e comunque, a fronte di una disciplina transitoria dettata per un periodo brevissimo (3 anni in un primo momento ed un quarto a seguito della recente proroga di applicazione) incombe sulle amministrazioni e sulla funzione pubblica la responsabilità per l’inadempimento contrattuale e/o il vuoto normativo creato. E’ infatti da precisare che nessun atto normativo e/o contrattuale ha fatto seguito alla norma di legge dal 2013 al 2015 (e c’è da scommetterci) non lo farà nemmeno nel 2016.
Premesso quanto sopra la domanda potrebbe essere questa: “Forse “le pari opportunità” riconosciute ai lavoratori padri della pubblica amministrazioni dello stato sono diverse da quelle del privato o forse sono “discriminabili” proprio in quanto lavoratori pubblici”
Ma a questo punto, in generale ci si potrebbe chiedere se può un parere del dipartimento della funzione pubblica (palesemente praeter legem) negare un diritto soggettivo da cui derivano peraltro obblighi previdenziali e retributivi ai dipendenti dello stato e non a quelli degli enti locali. E, soprattutto, che fine ha fatto la contrattazione nel pubblico impiego?
Ad avviso dello scrivente è maturo il tempo affinché si definiscano regole chiare sulla cosiddetta contrattualizzazione e sulle modalità applicative. Ciò non solo per raggiungere il cosiddetto “benessere organizzativo” ma per i l corretto funzionamento e l’organizzazione complessiva di tutto l’apparato della pubblica amministrazione. La certezza dei comportamenti del pubblico impiego si deve basare, difatti, non su scelte datoriali opportunistiche ma su certezze consolidate che implementino la stima e la fiducia che tutti (compresi i pubblici dipendenti) nutrono nei confronti del datore di lavoro pubblico. Questo, ad avviso di chi scrive, costituisce il presupposto indefettibile per un approccio seriamente innovativo alla macchina pubblica, nel rispetto delle regole interne ed esterne e del principio del buon andamento ed imparzialità del pubblico impiego, al di la di ogni slogan politico e propagandistico. 
Note
 [1] I successivi decreti Bassanini (Legge 15 marzo 1997, n. 59, Legge 15 maggio 1997, n. 127, Legge 16 giugno 1998, n. 191 Legge 8 marzo 1999 n. 50) puntualizzeranno questa “rivoluzione copernicana.
[1] I successivi decreti Bassanini (Legge 15 marzo 1997, n. 59, Legge 15 maggio 1997, n. 127, Legge 16 giugno 1998, n. 191 Legge 8 marzo 1999 n. 50) puntualizzeranno questa “rivoluzione copernicana.
[2] Attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15 (cd. Legge Brunetta).
[3] Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. La legge è costituita da 23 articoli, così suddivisi: artt. 1-7: semplificazioni amministrative; artt. 8-10: organizzazione; artt. 11-15: personale; artt. 16-23: deleghe per la semplificazione normativa.
[4] Emblematico in questo senso è, ad esempio, la eliminazione completa della possibilità per i dipendenti pubblici di impugnazione delle sanzioni disciplinari tramite rimedi extragiudiziari (come avviene nel privato attraverso l’applicazione dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300) e la necessità di ricorrere obbligatoriamente ad un giudice con tutte le conseguenze economiche che da questo derivano.
[5] Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
[6] Prof Sciarrone, COMPLICI, SOCI E ALLEATI. UNA RICERCA SULL’AREA GRIGIA DELLA MAFIA, su Studi sulla questione criminale, vii, n. 1, 2012, pg. 68.
[7] Confusione in quanto non si agisce in base ad un progetto predeterminato ma sulla base di un grande dinamismo privato ed un grande disordine pubblico dove vince la casta più forte in quel momento. Vedi sul punto l’interessantissimo studio sociologico del Prof. C.Trigilia, Dinamismo privato e disordine pubblico, in F. Barbagallo, Storia dell’Italia repubblicana. La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, Einaudi, Torino 1995, pp. 711-77.
[8] Emblematica, in al senso, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 in merito al blocco dei contratti pubblici, ove i Giudici ermellini evidenziano che siffatto blocco viola il principio di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione rispetto al lavoro prestato. La Corte afferma altresì che il blocco prolungato della contrattazione non può non configurare una violazione della libertà sindacale e della autonomia negoziale. Purtuttavia ritiene che la sentenza non abbia valore retroattivo, ma solo, pro futuro, per i pubblici dipendenti, accantonando velocemente la questione relativa alla parità di trattamento rispetto ai dipendenti privati, per i quali sono invece avvenuti gli incrementi contrattuali e non vi è stato alcun blocco contrattuale. Sul punto la stessa Corte Costituzionale richiama anche l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per il quale il credito del lavoratore si configura come proprietà. (Si veda Grande Camera, sentenza 12 novembre 2008, Demir e Baykara contro Turchia, riguardante il diritto di stipulare contratti collettivi nel lavoro pubblico).
[9] Art. 2 l. 190/1985: “La categoria dei quadri è costituita da prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”.
[10] Lo stesso art. 2095 cod. civ., al II° comma, opera un rinvio alla contrattazione collettiva, senza che in passato ciò abbia mai impedito la rivendicazione delle categorie di operaio, impiegato e dirigente in difetto di uno specifico intervento della disciplina contrattuale collettiva. Sul punto “Il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria”. Si veda, in tal senso anche Cass. 27.2.1995 n. 2246, e v. anche, Cass. 2.12.1998 n. 12214 che espressamente sostiene “Va, dunque, affermato che, laddove la normativa collettiva non provveda con norme proprie a dare attuazione alla legge, il giudice possa attribuire la qualifica di quadro al lavoratore dipendente sulla base delle indicazioni specifiche poste dalla legge n. 190/1985 (...)”.
[11] L’art. 40 così come descritto è stato abrogato dall’art 54, comma 1, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
 [12] Si veda l’art. 17 bis del d.lgs. 165/2001.
[12] Si veda l’art. 17 bis del d.lgs. 165/2001.
[13] Spesso capita che la somma recuperata a seguito di riqualificazione viene riassorbita dal mancato incremento contrattuale degli ultimi sei anni o, peggio ancora, in relazione allo scaglione fiscale di appartenenza, dal cosiddetto “Bonus Renzi” di 8o euro così come previsto dal D. L. n. 66/2014, all’art. 1.
[14] L’ARAN e i Sindacati Confederali, in data 21.06.2001:“L'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri – del 16 febbraio 1999 è confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria di Quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all'automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico (ex art. 40 del d.lgs. 165/2001).
[15] Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 14193 del 05.07.2005.
[16] Vedi art. 5 della legge 7 agosto 2012 n. 135.
[17] Vedi giurisprudenza supra.
[18] Vedi l’ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative areee dirigenziali per il triennio 2016/2018 sottoscritta in data 5 aprile 2016.
[19] Vedi Direttiva comunitaria n. 93/104/CE e successive modifiche.
[20] Vedi parere ARAN del 07/08/2012.
[21] Si rammenta che In base a tale accordo le ferie possono essere differite solo per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) e solo per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione).
[22] Ad esempio gli Enti pubblici locali hanno preferito seguire, in massa, il dettato legislativo, non essendo per essi vincolanti le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.
[23] La nota è stata ripresa dall’INPS con circolare n. 40 del 14/03/2013 di analogo contenuto.
[*] Coordinatore amministrativo della D.T.L. di Cuneo e componente del Centro Studi presso la D.G. ispettiva del Ministero del Lavoro. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.



Seguiteci su Facebook