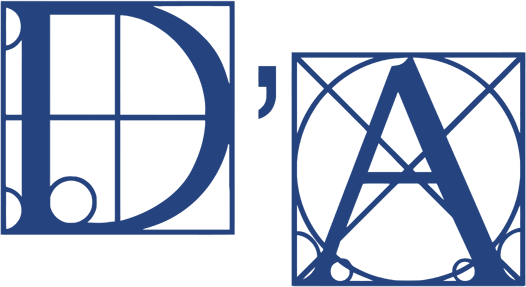
Alcune domande sul fenomeno del mobbing
di Katia Elisabetta Provenzano [*]
 Può definirsi mobbing il prolungato atteggiamento ostile da parte del datore di lavoro che si risolve in una sostanziale emarginazione dalla vita attiva lavorativa o, comunque, in un suo arbitrario e ingiustificato demansionamento?
Può definirsi mobbing il prolungato atteggiamento ostile da parte del datore di lavoro che si risolve in una sostanziale emarginazione dalla vita attiva lavorativa o, comunque, in un suo arbitrario e ingiustificato demansionamento?
Qualsivoglia risposta si intenda scegliere (nel senso del riconoscimento dei canoni di corretta amministrazione del rapporto di lavoro o viceversa nel senso della configurabilità di un pregiudizio subito per effetto di una serie di condotte asseritamente illecite tenute dai superiori) occorre innanzitutto delimitare il campo di indagine e partire dalla nozione di mobbing offerta dalla giurisprudenza, nonché dalle acquisizioni della scienza medico legale[1].
L’espressione inglese mobbing individua una condotta complessa, continuata e protratta nel tempo, posta in essere dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico o anche da parte di altri dipendenti sottoposti al potere direttivo dei primo[2] e tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro. La condotta poi si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili o apparentemente neutri o esorbitanti o incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto ed è espressione di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore. Quest’ultimo, poi, a causa di tali comportamenti, accuserà effetti lesivi alla salute psicofisica.
Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva di mobbing, si dovrà accertare in sede giudiziale la presenza di una pluralità di elementi costitutivi dati:
- dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio[3];
- dall'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- dal nesso eziologico tra le condotte sopra descritte e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
- dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi[4]. Sotto il profilo del rilievo del fattore psicologico del datore di lavoro, è stato puntualizzato dalla giurisprudenza che l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing [5].
Accanto agli elementi sopra declinati, vanno poi menzionate, per una maggiore comprensione del fenomeno mobbing, le problematicità riscontrate dal passaggio dalla definizione scientifico giuridica alla dimostrazione del fatto storico denunciato dal lavoratore. In sede giudiziale, infatti, non sempre si riesce a provare la sussistenza di un nesso causale tra i provvedimenti adottati dal datore di lavoro e i danni sofferti quale conseguenza dei primi. In questo senso di può osservare che la maggior parte delle sentenze richiamate in nota ha giudicato infondate le pretese risarcitorie a titolo di mobbing.
Quindi, al fine di escludere che si tratti di ordinaria amministrazione del rapporto di lavoro e degli uffici e poter affermare al contrario che si discuta di un insieme di condotte datoriali da cui emerge l'intento persecutorio nei confronti del dipendente, è necessario dimostrare che tutti gli atti posti in essere dal datore di lavoro si inseriscono in una strategia complessiva diretta all'emarginazione e al definitivo allontanamento del lavoratore dal contesto lavorativo.
Così argomentando, in un ipotetico giudizio di mobbing, la condotta andrà esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore: egli non potrà, pertanto, limitarsi davanti al giudice a dolersi genericamente di esser vittima di un illecito, ma dovrà quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice, anche con i suoi poteri ufficiosi, potrà verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo danno[6].
Perciò, occorrerà dimostrare l'esistenza di disagi e pressioni configurabili in termini di mobbing e occorrerà procedere per tempo impugnando tutti i provvedimenti posti in essere dal datore di lavoro nel perseguire l’intento criminoso[7].
Infatti, solo dove risulti espletata in sede istruttoria la sussistenza di un chiaro intento persecutorio e discriminatorio degli organi di vertice e sia altresì emerso che tale intento si concretizzi in un sostanziale svuotamento della prestazione lavorativa protratto nel tempo, arrecando al dipendente una lesione della personalità, allora si potrà argomentare una vittoria in termini di riconoscimento del mobbing e di risarcimento danni subiti[8].
Nell'ambito specifico del pubblico impiego, viene in luce un ulteriore elemento da considerare e cioè che l'intento persecutorio posto in essere dal dirigente possa, tra l'altro, dare luogo in sede penale al reato di abuso continuato d'ufficio (art. 323 c.p.).
Quanto ora affermato postula una ulteriore questione sul fenomeno del mobbing e cioè se sia sufficiente collocare la fattispecie nell’area civilistica, o se invece contenga quei caratteri necessari affinché valga la pena delinearla all’interno della sfera del penalmente rilevante, travalicando così i confini civilistici o giuslavoristici.
Sino a oggi le due aree si sono intersecate e a volte anche sommate; i giudici hanno ricondotto il mobbing ora nell’ambito del penalmente rilevante (richiamando articoli del codice penale collocati tra le norme a tutela della persona), ora nell’alveo del diritto civile (richiamando le norme in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale), ora infine a entrambi i profili.
In particolare, poi, quando il mobber riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la condotta mobbizzante è da parte della giurisprudenza penale configurata nel reato di cui all’art. 323 c.p., con conseguente esclusione di ogni altro crimine[9].
 Infatti, il delitto contro la Pubblica Amministrazione può essere commesso da un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La dottrina precisa che “l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto (deve essere) voluto dall’agente e non semplicemente previsto e accettato come possibile conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta a un fine pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Ciò, beninteso, a patto che il perseguimento di tale fine non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta. Ne deriva che per escludere il dolo sotto il profilo dell’intenzionalità occorre ritenere, con ragionevole certezza che l’agente si proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio”
[10].
Infatti, il delitto contro la Pubblica Amministrazione può essere commesso da un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La dottrina precisa che “l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto (deve essere) voluto dall’agente e non semplicemente previsto e accettato come possibile conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta a un fine pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Ciò, beninteso, a patto che il perseguimento di tale fine non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta. Ne deriva che per escludere il dolo sotto il profilo dell’intenzionalità occorre ritenere, con ragionevole certezza che l’agente si proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio”
[10].
Questi principi ben si prestano nel caso del mobbing: il mobber persegue un fine che non è mai legittimo e v’è sempre una violazione di legge e un danno ingiusto per la vittima, anche se non sempre un ingiusto vantaggio patrimoniale per il mobber.
La Corte di cassazione chiamata a pronunziarsi sulla configurabilità del delitto di abuso di ufficio ha affermato che tanto l’adibizione a mansioni inferiori senza rispetto della procedura per l’individuazione a rotazione dei soggetti destinati a svolgere le stesse[11], quanto la mancata verifica circa l’idoneità professionale della lavoratrice alla nuova temporanea mansione, rappresentano “il suggello di tutta una serie di elementi caratterizzanti quel fenomeno sociale noto come mobbing, consistente in atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico che mira a danneggiare il dipendente, così da coartarne o da piegarne la volontà: comportamenti tesi, nella fattispecie, a dequalificare professionalmente la parte lesa, tali da concretare oltre che il reato di abuso di ufficio in danno di costei, da integrare altresì l’illecito di cui all’art. 2043 c.c., essendo derivata, quale ulteriore conseguenza di ulteriori comportamenti mobbizzanti (del datore di lavoro), una seria patologia neuro psichiatrica a carico della lavoratrice; attività amministrativa illegittima, dunque, da cui è derivata, in una con la lesione dell’interesse legittimo in sé considerato, quella dell’interesse al bene della vita, che risulta meritevole di protezione, con conseguente risarcibilità del danno causato”
[12].
In conclusione quale che sia la tutela apprestata tanto nel caso di abuso di ufficio quanto per i diversi reati configurabili, la garanzia offerta al soggetto molestato è limitata: si condanna il mobber soltanto per l’ultimo comportamento vessatorio commesso, posto che, finalmente, egli è ‘uscito allo scoperto’ adottando, come nel caso in esame, un provvedimento illegittimo che ben s’inquadra in un disegno criminoso teso a dequalificare professionalmente la parte lesa.
Infine un’osservazione. In una prospettiva de iure condendo potremmo chiederci se nell’ordinamento penale sia necessario introdurre un delitto di violenza psicologica sul luogo di lavoro.
 Sul punto la dottrina non pare unanime. Sul fronte del sì, si schierano quanti vedono nel diritto penale la branca del diritto che in via primaria assolve al compito di proteggere la persona umana nella società. Secondo quest’orientamento dunque “il diritto penale è un potente fattore di socializzazione: non soltanto con la minaccia della sanzione e la relativa intimidazione, ma anche, e soprattutto, con la rappresentazione dei confini della libertà di agire che diffonde e l’adeguamento spontaneo che suggerisce, esso determina e rafforza in generale l’atteggiamento di conformità al diritto e alle esigenze della vita associata”
[13].
Sul punto la dottrina non pare unanime. Sul fronte del sì, si schierano quanti vedono nel diritto penale la branca del diritto che in via primaria assolve al compito di proteggere la persona umana nella società. Secondo quest’orientamento dunque “il diritto penale è un potente fattore di socializzazione: non soltanto con la minaccia della sanzione e la relativa intimidazione, ma anche, e soprattutto, con la rappresentazione dei confini della libertà di agire che diffonde e l’adeguamento spontaneo che suggerisce, esso determina e rafforza in generale l’atteggiamento di conformità al diritto e alle esigenze della vita associata”
[13].
Certo non può non cogliersi, ricordando autorevole dottrina, il rischio di una deriva eticizzante del diritto penale laddove se ne voglia enfatizzare il ruolo fortemente simbolico del diritto penale. Pertanto non deve “sfociare nella convinzione che sussista un nesso di implicazione necessaria tra la scelta della sanzione penale e la qualità del rango o del bene tutelato: ciò porterebbe anche inconsapevolmente al ribaltamento dell’assunto iniziale che l’eventuale rilievo costituzionale del bene non si traduce in un obbligo di penalizzazione a carico del legislatore ordinario”
[14].
Certamente occorre interrogarsi se si tratta di un bene giuridico che giustifichi la necessità o il bisogno di una pena diversa rispetto a quelle già codificate, cui la magistratura ha in questi anni fatto riferimento anche se in via mediata per contenere e punire le condotte vessatorie[15]; ma principalmente “prima di auspicare un’organica tutela penale, si deve verificare se (il bene giuridico da presidiare con la sanzione penale) non soffra soprattutto di un vuoto di tutela civilistica. È quest’ultimo un passaggio obbligatorio per il penalista che spesso si dimentica del carattere di extrema ratio che deve connotare lo strumento sanzionatorio penale”
[16]. ![]()
Note
[1] Di tale istituto non esiste una definizione normativa. Basta solo ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 dicembre 2003, n. 359, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della regione Lazio 11 luglio 2002 n. 16, che ne aveva dato una definizione giuridica, per violazione del principio secondo cui spetta allo Stato fornire la nozione giuridica di un fenomeno inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento civile, ed ancora che la circolare Inail n. 71 del 2003, che aveva inserito tra le malattie tabellate anche quelle psichiche da mobbing, è stata annullata da Tar Lazio, sez. III ter, n. 5454/2005. La dottrina fa derivare il vocabolomobbing dal verbo anglosassone “to mob” traducibile con i verbi italiani “affollarsi, accalcarsi intorno a qualcuno, assalire tumultuando, malmenare, aggredire”; mentre il sostantivo “mob” deriva dal latino “mobile vulgus” e significa “assalto collettivo da parte della plebaglia in tumulto". Sebbene si utilizzi un vocabolo inglese, il fenomeno è stato messo a fuoco nel contesto di studi in lingua tedesca, svedese, norvegese e finlandese. In dottrina, tra i diversi autori che hanno studiato il fenomeno, si rinvia a Scognamiglio R., A proposito del mobbing, in RIDL, 2004, I, p. 490; Monateri P.G., Bona M., Oliva U., Mobbing. Vessazioni sul lavoro, Milano: Giuffré, 2000, p. 6; Ege H., La valutazione peritale del danno da mobbing, Milano: Giuffré, 2002, p. 7). Inoltre si rimanda ai sette parametri tassativi di riconoscimento del mobbing individuati dalle scienze e che sono: l'ambiente; la durata, la frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l'andamento secondo fasi successive , l'intento persecutorio.
[2] Sulla questione specifica della responsabilità del datore di lavoro, la giurisprudenza ha in più occasioni specificato che non è scriminatura il datore di lavoro dal danno arrecato al dipendente per il fatto che l’azione mobbizzante sia posta in essere da un soggetto diverso ma pur sempre facente capo all’organizzazione, dal momento che sul datore di lavoro incombono gli obblighi di cui all'art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo (Cass. 15.05. 2015 n. 10037).
[3] In questi termini si rinvia a: Cons. St. sez. IV, 19.03.2013, n. 1609 secondo cui il fenomeno del mobbing può essere individuato alla luce di una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti: l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente, deve essere posta in essere con una serie prolungata di atti e deve avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi. Di contro non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria, essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro; più recentemente si rinvia a Cass. sez. lav., 6.08.2014 n. 17698 ed a Cass. sez. lav. 28.04.2015 n. 8581.
 [4] Si vedano al riguardo: Cons. St., sez. IV, 6.08.2013, n. 4135; Cons. St. sez. VI, 12.03.2012, n. 1388.
[4] Si vedano al riguardo: Cons. St., sez. IV, 6.08.2013, n. 4135; Cons. St. sez. VI, 12.03.2012, n. 1388.
[5] Si rinvia a Cons. St., sez. IV, 16.02.2012, n. 815.
[6] Il riferimento è ancora a Cons. St. sez. IV 6.08.2013 n. 4135.
[7] In questi termini Cons. St. , sez. III , 5.02.2015 n. 549.
[8] In questa sede ci si permette soltanto di osservare come il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa esuli dall'ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi qui la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. sez. lav. 21.05.2009 n. 11835).
[9] Come accennato, nel contesto normativo nazionale non esiste una fattispecie di mobbing. Allo stato, le condotte di mobbing possono essere inquadrati oltre che nel reato di abuso di ufficio, ora nell’alveo del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), ora tra i reati di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) o colpose (art. 590 c.p.), di violenza sessuale connessa con l’abuso di autorità (art. 609 bis), di (tentata) violenza privata (art. 610 c.p.), di estorsione (art. 629 c.p.), di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.).
[10] Cass. pen. 7.11.2007, n. 40891; Cass. pen. 11.05.2007.
[11] Il provvedimento amministrativo illegittimo disponeva l’adibizione a mansioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (anziché le proprie mansioni di economa presso l’asilo comunale) per un limitato periodo che complessivamente non superava i 14 giorni.
[12] Cass. pen. 7.11.2007, n. 40891.
[13] Romano M., Sub art. 1 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, Milano: Giuffrè, vol. I, p.
[14] Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Parte generale, 4 ed., Bologna, p. 40
[15] Questo è ad esempio quanto è avvenuto in Francia con la legge di modernizzazione sociale n. 73/2002 con cui si è proceduto alla codificazione di una fattispecie introdotta nel codice penale: la molestia morale. In dottrina si rinvia alle puntuali osservazioni di Sansone M., Prospettive di una penalizzazione del mobbing, in RP 2006, fasc.9, in www.latribuna.it.
[16] Bricola F., Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in RIDPP, 1967, p. 1079 ss., ora in Scritti di diritto penale, 1997, vol. II, Milano:Giuffrè, p. 2353
[*] Avvocato e Dottore di ricerca in diritto del lavoro e previdenza sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Funzionario ispettivo presso la Direzione Territoriale del lavoro di Torino ove si occupa di attività istruttoria ricorsi al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro istituito presso la DIL di Milano. Vincitrice 2009 del “Premio Massimo D’Antona”. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.



Seguiteci su Facebook