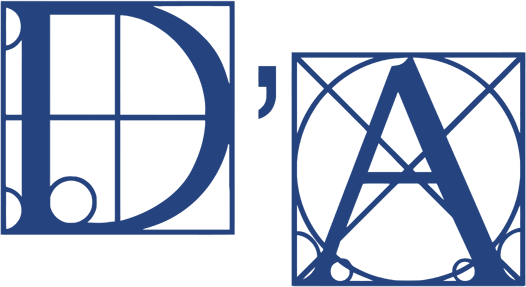
Lavoro e povertà
di Stefano Olivieri Pennesi [*]
 Il fenomeno sociale cui assistiamo nel nostro Paese che intendiamo affrontare e che si sta preoccupantemente diffondendo, in maniera esponenziale, si sostanzia nel fatto che sempre più frequentemente il detenere un “lavoro” non è garanzia di allontanamento dalla povertà, se vogliamo una non protezione.
Il fenomeno sociale cui assistiamo nel nostro Paese che intendiamo affrontare e che si sta preoccupantemente diffondendo, in maniera esponenziale, si sostanzia nel fatto che sempre più frequentemente il detenere un “lavoro” non è garanzia di allontanamento dalla povertà, se vogliamo una non protezione.
La cosa assume connotati di gravità se confrontiamo epoche diverse, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, alla luce del fatto che, in passato, possedere un impiego, anche di natura operaia od agricola, rappresentava comunque sinonimo di “non povertà”, magari e certamente non benessere, ma quasi sempre significante l’appartenenza ad un ceto medio-basso, lontano però dal considerarsi “povero” e quindi al margine della società.
Oggi, invece, gli eventi economici, ma anche l’elevazione degli standard dei consumi e quindi dei bisogni dei nostri nuclei familiari, hanno spinto fasce di cittadini verso le periferie delle categorie sociali, sia quelle localizzate nelle metropoli urbane e suburbane, sia anche quelle residenti in piccoli borghi cittadine e/o zone rurali.
I lavoratori che possiamo definire poveri non sono soltanto quelli che posseggono redditi bassi o molto bassi o anche legati a tipologie contrattuali atipiche, precarie, o comunque intermittenti, o ancora caratterizzate da presenza di periodi di “cassa integrazione”, contratti di solidarietà, part time, tutte situazioni, queste, che conducono ad una contrazione salariale, anche consistente. In una parola, povertà e anche vivere con redditi fortemente decurtati, soprattutto con il perdurare di una gravissima crisi economica che si lega alla conseguente riduzione di domanda di beni e di servizi.
Non da ultimo è bene dirlo vi è il problema di salari che, anche se in linea con la media dei contratti collettivi vigenti (non parliamo quindi di situazioni di sfruttamento e/o lavoro nero) debbono sostenere nuclei familiari di tre, quattro, cinque componenti, rivelandosi, quindi, assolutamente insufficienti oggi giorno; questo è sempre più frequente nelle regioni del meridione dove la crisi, da un lato, nonchè la endemica/cronica penuria di occupazione e lavoro, da l’altro, producono sacche di grave indigenza.
Contrastare la povertà di questa natura e con questi connotati, nella sua recente versione, dovrebbe rappresentare uno dei maggiori e più importanti obiettivi della nostra classe politica dirigente, su questo, però, possiamo osservare solamente timidi sforzi.
È indispensabile promuovere progetti affiancati da normative cogenti, in grado di soddisfare il bisogno di aggredire, con tutte le forze, disponibili, queste nuove forme di povertà contrastandone gli effetti virali sull’economia e sul benessere di un Paese moderno, quale è l’Italia.
Per il vero, in passato, il fenomeno della povertà e quindi dell’essere poveri è stato fatto confluire e relegato, quindi, nel contesto generale della complessiva “assistenza ai bisognosi”, un problema, perciò, concretamente delegato alla rete degli enti caritatevoli – onlus, quale ad esempio la Caritas, come anche, fino quando le risorse finanziarie assegnate e gestite dagli enti locali lo permettevano, alle strutture pubbliche dedicate alla assistenza sociale.
In concreto, in Italia, si è rilevata, ma si rileva ancora, la quasi totale “assenza” di politiche pubbliche specifiche di contrasto vero alle varie forme di povertà, in sostanza la cultura politica del nostro Paese e le azioni conseguenti hanno, di fatto, declinato la tematica generale della povertà a questione prettamente di natura caritatevole ed assistenziale “passiva”.
Da qui trova, pertanto, fondamento la questione attinente il cosiddetto “reddito minimo” che in Italia è allo stato inesistente, al contrario della stragrande maggioranza dei Paesi europei che invece lo contemplano nel loro ordinamento, ad eccezione solamente di Grecia e Bulgaria.
Sicuramente, questo istituto, sconterebbe effetti forse controproducenti, quale elemento di “assistenzialismo passivo”, ma al contempo fornirebbe, comunque, quella scialuppa di salvataggio per le persone e nuclei familiari che, nella loro vita, possono imbattersi in situazioni di emergenza legata sempre più spesso alla perdita di lavoro parziale come totale.
Ciò al fine di fornire mezzi minimi di sostentamento per i bisogni fondamentali di vita, anche alla luce della ormai platea, in continua crescita, dei quasi dieci milioni di indigenti rilevati dalle più recenti statistiche sulla povertà nel Paese di cui oltre un milione e mezzo di bambini e adolescenti.
Per il vero un altro elemento rilevante, da evidenziare, è rappresentato dal fatto che le scarse azioni e le politiche di contrasto alla indigenza, o più in generale alla povertà, non hanno connotati di globalità o generalità particolari, sono invece, di contro, lasciate nella loro parcellizzazione e scelte localistiche settoriali, regionali, per meglio dire attuate in modalità disorganiche e soprattutto legate ad iniziative di amministratori e politici illuminati, nell’azione sui territori di proprio interesse.
 A conforto di queste mie tesi basta osservare quanto deliberato o in via di discussione, rispetto a risorse e normative adottate, ad esempio in tema di reddito minimo, nelle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Piemonte, Sicilia; come anche nelle Province autonome di Bolzano e Trento; ma pure come avviene in diverse municipalità della Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.
A conforto di queste mie tesi basta osservare quanto deliberato o in via di discussione, rispetto a risorse e normative adottate, ad esempio in tema di reddito minimo, nelle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Piemonte, Sicilia; come anche nelle Province autonome di Bolzano e Trento; ma pure come avviene in diverse municipalità della Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.
Ciò detto, però, è innegabile il fatto che risulta pressochè assente una iniziativa unitaria e uniformante, su tali problematiche, stenta a sostanziarsi, una regia univoca che definisce ad esempio livelli minimi essenziali di assistenza, dal punto di vista reddituale e sociale, magari ponderandoli a seconda delle realtà territoriali.
Criteri comuni ed uniformi per accedere a forme di sostegno, con similari ponderazioni, anche alla luce delle composizioni familiari con presenza o meno di figli minori, rappresentando questi un oggettivo costo differenziale, di notevole impatto.
Per tornare al binomio Lavoro-Povertà è utile introdurre una riflessione circa la differenza esistente tra chi un lavoro lo possiede, ancorchè ridotto ed intermittente, laddove i contratti collettivi e le norme lavoristiche prevedano una parte minima di retribuzione, sottoforma di assegno per figli e familiari a carico; e chi invece, nella qualità di disoccupato o lavoratore autonomo, non può disporre di queste integrazioni e/o indennità accessorie al reddito di lavoro puro.
Ecco quindi che aiutare ed incentivare il lavoro femminile come anche l’ingresso delle giovani leve, renderebbe più agevole affrontare meglio crisi economiche quale l’attuale. Non da meno, per agevolare gli ingressi nel mondo del lavoro, si dovrebbero aumentare gli sforzi tendenti ad una maggiore attenzione alla tematica “conciliazione tempi di vita e di lavoro”, come anche pendolarismo e mobilità, per contrastare il fenomeno certamente presente e in maniera maggiore nel meridione, di rinuncia alla ricerca di lavoro per “cause involontarie" e/o scoraggiamento.
Torniamo al tema di fondo dell’assenza di lavoro, che è abbinata spesso alla presenza di figli, e questi rappresentano, talvolta, i fattori determinanti che spingono le famiglie italiane incontro alla povertà. Perdere il lavoro, o non averlo affatto, unitamente alla presenza di figli, in uno status che si prolunga nel tempo, in costanza appunto di crisi economiche, inevitabilmente conduce a stati di indigenza, ancorchè alleviata parzialmente, stante la specificità e la tradizione del nostro Paese di detenere e formare quella rete di protezione sociale, naturale, rappresentata da familiari come i genitori, i nonni, i fratelli e sorelle, i figli adulti.
Dati Istat ci dicono che in Italia circa una famiglia su cinque, con oltre un milione e mezzo di minori, vive al di sotto della soglia di povertà, il problema lavoro è determinante soprattutto per le note difficoltà di reperirlo in particolare anche per coloro che ne perdono uno ed hanno bisogno di ricollocarsi ma anche riqualificarsi professionalmente.
Anche gli stati di malattia con patologie gravi, più o meno lunghe, rappresentano oggi un fattore di rischio (vedi ad esempio le vicende Ilva di Taranto, Monfalcone, Casale Monferrato, Italsider di Bagnoli, Breda costruzioni ferrovie, ecc.).
Tornando ai dati Istat si rileva che la crisi, dal 2008 al 2014, ha causato l’aumento di oltre 1/3 del tasso di povertà detenuto dal Paese, con un incremento di oltre quattro milioni dei cosiddetti “poveri assoluti”.
La povertà in Italia ha rappresentato nel 2014 il coinvolgimento del 5,7% delle famiglie in povertà assoluta, e il 10,3% di quella definita in povertà relativa. La soglia di reddito spendibile, che calcola l’Istituto statistico, sotto la quale ci si trova in povertà assoluta, per un nucleo di quattro persone, è di circa 1.100 euro. Mentre, per la povertà relativa, con gli stessi parametri, la somma si aggira a circa 1.600 euro.
In definitiva il Paese annovera circa tra i nove e i dieci milioni di cittadini, in posizione di povertà, di cui sei milioni circa in povertà assoluta ossia, che non detengono redditi per sostenersi; e con l’aumento vertiginoso della povertà, anche le conseguenti disuguaglianze aumentano significativamente.
È bene ora volgere anche uno sguardo sul tema della povertà legata ai “pensionati poveri”. Dalle tabelle Inps, dell’ultimo Rapporto annuale, possiamo estrapolare il dato riguardante la distribuzione, per fasce di reddito, delle pensioni erogate dall’Ente Previdenziale, in particolare la fascia per classe di importo compresa fino a 499 euro che risulta essere il 12,1% dei pensionati totali e che rappresentano solamente, il 2,6% sulla spesa complessiva annua delle prestazioni pensionistiche.
Significativo è anche il dato riguardante la fascia di importo compreso tra 500 e 999 euro che rappresenta il 30,4% dei pensionati totali, reddito quindi anch’esso non assolutamente idoneo per vivere dignitosamente.
Riflettendo quindi sui dati, possiamo anche affermare rispetto al tema principale, in questo scritto trattato, che la disuguaglianza pensionistica è certamente frutto anche della “disuguaglianza del mercato del lavoro” oltre che delle progressive e sovrapposte riforme previdenziali.
La povertà come problema collegato anche, oltre alla mancanza primaria di lavoro, al funzionamento del sistema di protezione sociale.
 Negli anni di questa crisi il 10% della popolazione più ricca ha perso solamente tra l’1 e il 5% del reddito, mentre il 10% più povero ha perso tra il 27 e il 30% del reddito, rendendo il Paese oggettivamente più fragile anche per l’assenza, come sopra accennato, di “ammortizzatori sociali universali”.
Negli anni di questa crisi il 10% della popolazione più ricca ha perso solamente tra l’1 e il 5% del reddito, mentre il 10% più povero ha perso tra il 27 e il 30% del reddito, rendendo il Paese oggettivamente più fragile anche per l’assenza, come sopra accennato, di “ammortizzatori sociali universali”.
L’unica vera strada per uscire dallo stato di povertà è consistente nel detenere un lavoro che produce “redditi certi e costanti”, questa è anche la tesi del Presidente dell’Inps Prof. Boeri. Avere o non avere un lavoro è il primo grande discrimine per l’incombenza del rischio povertà, ma altrettanto influente, su questo status sociale, è il disporre si di un lavoro ma che sia in grado di procurare reddito sufficiente non decurtato per i vari noti fattori economici, anche perché gli attuali sistemi di calcolo previdenziale, ci consegneranno, nel futuro, prestazioni pensionistiche direttamente collegate al reddito e conseguentemente all’accumulo contributivo realizzato durante la vita lavorativa, necessariamente, stanti le norme vigenti, sempre più lunga, ma meno proficua.
Concludiamo ora riflettendo su ciò che significa dignità del lavoro, che frequentemente si contrappone, nei fatti, al degrado umano ed etico. Esempio in tal senso è certamente lo sfruttamento del lavoro in forma schiavistica e disumanizzante, che troppo spesso si fonda sul bisogno assoluto di sostentamento vitale e nel produrre qualsivoglia reddito.
Non si può tollerare la schiavitù da lavoro di donne, uomini e spesso anche bambini, ci fa perdere dignità a favore di un profitto economico, di pochi e per pochi. Ciò altresì mette a rischio i ritmi umani di vita, che richiedono un tempo di riposo, un tempo per gli affetti, un tempo di cura, anche delle nostre menti. In una parola si rischia la privazione di una coscienza di vita, inaridendo legami, progetti e speranze.
Viviamo questa epoca dove, in maniera diametralmente opposta, convivono forme di partecipazione civile e singole solitudini connesse magari da reti sociali virtuali, dove anche risiedono nuove forme di lavoro ed economia, sempre più dematerializzate e comprese in vortici di processi produttivi distanti e globali.
Si produce sempre più in zone remote del globo dove la cultura dei diritti del lavoro è quasi o totalmente inesistente, ma non per questa meno agognata e necessaria. Ma quando si materializzano forme di sfruttamento ed umiliazioni, ad esempio nel nostro Bel Paese, nei nostri territori, questo ci fa improvvisamente destare dal sonno soporifero di una modernità, in parte subita, dalle nostre pigre coscienze.
È vero che il bisogno di lavoro è grande per ogni uomo, ma il rischio di perderlo non dovrebbe indurci ad accettare o fare accettare condizioni estreme per lavorare e sopravvivere, o almeno chi ha le leve politiche idonee, dovrebbe mettere in campo reti ed iniziative di protezione e tutela umana, partendo proprio dalle fasce più deboli e forse invisibili, dei lavoratori schiavi, poveri, ultimi… nell’attuale epoca 2.0. ![]()
[*] Professore a contratto c/o Università Tor Vergata, Roma – titolare della cattedra di “Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro”. Il Prof. Stefano Olivieri Pennesi è anche Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direttore della DTL di Prato.



Seguiteci su Facebook