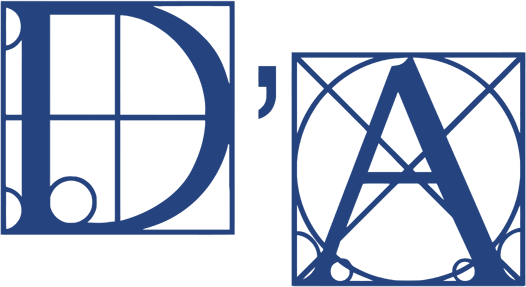
L’evoluzione storica del Terzo Settore: nascita e progressiva affermazione - Prima Parte
di Paola Di Paolo [*]
 Il concetto di Terzo Settore fa riferimento all’esistenza di un primo settore costituito dal mercato
e di un secondo settore costituito dallo Stato.
Tutto ciò che rientra nel Terzo Settore non è mercato né Stato. Il concetto si riferisce all’insieme di organizzazioni private che operano, senza scopo di lucro, per finalità di utilità sociale in vari settori. “Terzo settore” può essere definito come l’area delle iniziative autonome, di aiuto alle situazioni di bisogno.
Il concetto di Terzo Settore fa riferimento all’esistenza di un primo settore costituito dal mercato
e di un secondo settore costituito dallo Stato.
Tutto ciò che rientra nel Terzo Settore non è mercato né Stato. Il concetto si riferisce all’insieme di organizzazioni private che operano, senza scopo di lucro, per finalità di utilità sociale in vari settori. “Terzo settore” può essere definito come l’area delle iniziative autonome, di aiuto alle situazioni di bisogno.
Esso è un insieme di organizzazioni: formali in quanto dotate di uno Statuto che regola l’accesso dei membri, le relazioni reciproche e la stabilità nel tempo; private, in grado di decidere in autonomia; non profit che non prevedono distribuzione dei profitti ai soci; aconfessionali e non schierate politicamente, ossia non coinvolte direttamente in attività di partiti politici e di promozione di dottrine religiose. Il criterio fondamentale è che le organizzazioni operino per il “bene pubblico” e siano incluse nel settore del volontariato, la cui interpretazione è importante elemento di definizione di charity. [1]
In Italia, a partire dal Medioevo, l’assistenza ai poveri, era stata solitamente affidata all’iniziativa privata ed alle Congregazioni Religiose; e nel corso dei secoli erano nate numerose compagnie di beneficenza, finalizzate all’assistenza degli infermi, alla tutela degli orfani ed alla sepoltura dei morti. Il passaggio a forme pubbliche di assistenza si ebbe soltanto a partire dal ’600 quando fu emanata, in Inghilterra, la Poor Law (legge per i poveri), che attribuì alle parrocchie, sotto il controllo pubblico, la riscossione dei contributi obbligatori destinati ai bisognosi; inoltre creò laboratori per i poveri privi di lavoro e costituì un fondo per gli invalidi. In Italia, tale cambiamento investì l’intera società e la sua organizzazione assistenziale, costituita da una rete di istituzioni, largamente autonoma, che rappresentava la forma ordinaria di risposta ai bisogni emergenti, in una sorta di Terzo settore auto organizzato e basato sulla continuità dei lasciti e delle donazioni[2].
 I primi riscontri significativi si ritrovano nel Piemonte di Vittorio Amedeo II che, teorizzando sistemi di controllo della povertà e dell'emarginazione urbana, era pervenuto alla fondazione delle Congregazioni di carità. Nel 1716 a Torino con André Guevarre, gesuita riformatore degli istituti caritativi, fu creato un nuovo sistema che istituzionalizzava la carità individuale di tipo spontaneo sotto il controllo statale, mentre il potere civile sostituiva il clero nella gestione dell'assistenza. Si registrarono, però, posizioni contrastanti tra diversi economisti del tempo a proposito della carità legale. L’economista inglese Thomas Malthus sosteneva, infatti, che la tutela pubblica dei poveri si rivelasse controproducente, in quanto la costante assistenza garantita al lavoratore ed alla sua famiglia, inducevano la popolazione all’ozio. Egli sosteneva che dovessero essere abolite tutte le forme di assistenza pubblica. In Italia la posizione malthusiana venne accolta da molti economisti, tra i quali Melchiorre Gioia, che criticava le forme di assistenza ai poveri, sia pubbliche che private, in quanto le stesse aumentavano il numero degli assistiti e propose, come soluzione al problema dei poveri, la creazione di occasioni di lavoro e di reddito. Le autorità pubbliche avrebbero dovuto programmare le forme di job creating, lasciandole però in gestione ai privati[3]. Stesse posizioni furono assunte da Gian Domenico Romagnosi che individuava la causa della povertà non nell’irrazionale spinta alla riproduzione, ma nella violazione del naturale equilibrio economico[4], poiché la concentrazione della proprietà fondiaria e le misure protettive dell’industria e del commercio avevano prodotto una diffusa condizione di povertà che non poteva certo essere affrontata abolendo le “poor laws”. La libera concorrenza avrebbe prodotto, invece, un equilibrio tale che il pauperismo si sarebbe ridotto a fenomeno marginale. Carlo Ilarione Petitti di Roreto sosteneva il diritto – dovere del governo di prestare aiuto alla miseria quale tutore comune ed al tempo stesso del necessario equilibrio nei confronti delle istituzioni di cui andava rispettata l’autonomia[5].
I primi riscontri significativi si ritrovano nel Piemonte di Vittorio Amedeo II che, teorizzando sistemi di controllo della povertà e dell'emarginazione urbana, era pervenuto alla fondazione delle Congregazioni di carità. Nel 1716 a Torino con André Guevarre, gesuita riformatore degli istituti caritativi, fu creato un nuovo sistema che istituzionalizzava la carità individuale di tipo spontaneo sotto il controllo statale, mentre il potere civile sostituiva il clero nella gestione dell'assistenza. Si registrarono, però, posizioni contrastanti tra diversi economisti del tempo a proposito della carità legale. L’economista inglese Thomas Malthus sosteneva, infatti, che la tutela pubblica dei poveri si rivelasse controproducente, in quanto la costante assistenza garantita al lavoratore ed alla sua famiglia, inducevano la popolazione all’ozio. Egli sosteneva che dovessero essere abolite tutte le forme di assistenza pubblica. In Italia la posizione malthusiana venne accolta da molti economisti, tra i quali Melchiorre Gioia, che criticava le forme di assistenza ai poveri, sia pubbliche che private, in quanto le stesse aumentavano il numero degli assistiti e propose, come soluzione al problema dei poveri, la creazione di occasioni di lavoro e di reddito. Le autorità pubbliche avrebbero dovuto programmare le forme di job creating, lasciandole però in gestione ai privati[3]. Stesse posizioni furono assunte da Gian Domenico Romagnosi che individuava la causa della povertà non nell’irrazionale spinta alla riproduzione, ma nella violazione del naturale equilibrio economico[4], poiché la concentrazione della proprietà fondiaria e le misure protettive dell’industria e del commercio avevano prodotto una diffusa condizione di povertà che non poteva certo essere affrontata abolendo le “poor laws”. La libera concorrenza avrebbe prodotto, invece, un equilibrio tale che il pauperismo si sarebbe ridotto a fenomeno marginale. Carlo Ilarione Petitti di Roreto sosteneva il diritto – dovere del governo di prestare aiuto alla miseria quale tutore comune ed al tempo stesso del necessario equilibrio nei confronti delle istituzioni di cui andava rispettata l’autonomia[5].
Il problema della gestione della mendicità doveva essere affrontato con l’obiettivo di arrivare ad una corretta gestione amministrativa, assicurando il sostegno assistenziale a tutti coloro che erano effettivamente incapaci di provvedere a se stessi (poveri invalidi) ma anche a coloro che in situazioni congiunturali rimanevano disoccupati, e che erano disposti, perciò, a prestare il loro lavoro nelle “case d’industria”. Emerge come elemento comune, l’esigenza di circoscrivere l’area dell’assistenza e di potenziare la prevenzione. In quest’ottica viene ad assumere rilevanza la dottrina del “self help” in base a cui le classi bisognose venivano messe in grado di aiutarsi da sole. Si diffonde attraverso una intensa propaganda giornalistica l’ideologia della laboriosità, della previdenza e del risparmio. La responsabilità della miseria, in questa prospettiva, veniva così attribuita all’operaio imprevidente.
Nella seconda metà dell’800 in Italia il “sistema di carità”, nei diversi Stati della Penisola, era articolato in una rete di Opere Pie – così come vennero chiamate nella Gran Legge n. 753/1862, che comprendeva “i luoghi pii”, elemosinieri come espressione dell’associazionismo confraternale, gli “Ospedali maggiori”, di fondazione quattrocentesca, i “Monti di pietà”, sorti ad opera della predicazione francescana, le strutture nate dalla riforma cattolica, quali orfanotrofi, ospizi e “ritiri” femminili che scaturivano dalla tradizione medioevale[6].
 Inoltre erano presenti le corporazioni di mestiere che svolgevano una specifica attività assistenziale basata sulla mutua solidarietà[7]. In Piemonte si venne a manifestare il modello del “glorioso Piemonte della carità”
con una ricchezza di iniziative che rendevano Torino una risposta a un gravissimo disagio economico e sociale. Si evidenziava un concreto interesse per la solidarietà sociale, da cui originavano opere di grande rilievo per l’intera società italiana, come quelle attivate da Giuseppe Benedetto Cottolengo e da don Giovanni Bosco. Accanto a questi personaggi eccezionali c’erano altre figure di benefattori, spesso appartenenti al mondo aristocratico; tra essi Giulia di Barolo che si impegnò in particolare nella tutela del mondo femminile. Ad essa si deve la fondazione di opere di assistenza per le recluse nella prigione femminile e per le donne traviate che intendessero cambiar vita, di ospedali per le donne, di educandati per le orfane, di scuole femminili e di Associazioni di dame per la visita ai poveri a domicilio. L’assistenza privata era affidata quindi ad istituti di derivazione medioevale. Dal 1807 nacquero le Congregazioni di Carità che unificarono la gestione dell’assistenza e della sanità sul piano Comunale. Il controllo statale, esercitato tramite le Prefetture, era molto stretto ma la gestione era di fatto delegata ai notabilati locali che nominavano i membri delle Congregazioni stesse e i benefattori[8], intorno alle quali si sviluppò un vasto piano di sostegno ai poveri “validi” con le “case d’industria” ed ai poveri “invalidi” con le “case di ricovero”
[9].
Inoltre erano presenti le corporazioni di mestiere che svolgevano una specifica attività assistenziale basata sulla mutua solidarietà[7]. In Piemonte si venne a manifestare il modello del “glorioso Piemonte della carità”
con una ricchezza di iniziative che rendevano Torino una risposta a un gravissimo disagio economico e sociale. Si evidenziava un concreto interesse per la solidarietà sociale, da cui originavano opere di grande rilievo per l’intera società italiana, come quelle attivate da Giuseppe Benedetto Cottolengo e da don Giovanni Bosco. Accanto a questi personaggi eccezionali c’erano altre figure di benefattori, spesso appartenenti al mondo aristocratico; tra essi Giulia di Barolo che si impegnò in particolare nella tutela del mondo femminile. Ad essa si deve la fondazione di opere di assistenza per le recluse nella prigione femminile e per le donne traviate che intendessero cambiar vita, di ospedali per le donne, di educandati per le orfane, di scuole femminili e di Associazioni di dame per la visita ai poveri a domicilio. L’assistenza privata era affidata quindi ad istituti di derivazione medioevale. Dal 1807 nacquero le Congregazioni di Carità che unificarono la gestione dell’assistenza e della sanità sul piano Comunale. Il controllo statale, esercitato tramite le Prefetture, era molto stretto ma la gestione era di fatto delegata ai notabilati locali che nominavano i membri delle Congregazioni stesse e i benefattori[8], intorno alle quali si sviluppò un vasto piano di sostegno ai poveri “validi” con le “case d’industria” ed ai poveri “invalidi” con le “case di ricovero”
[9].
Le Congregazioni di carità istituite nel 1807 sul modello francese dei bureaux de bienfaisance erano di composizione mista laico–ecclesiastica, con funzione di amministrazione in ogni Diocesi, i conservatori, gli ospedali e le fondazioni di carità. Alle Congregazioni, presiedute dal Prefetto, dal Podestà o dal Sindaco, partecipavano il Vescovo ed altri membri designati tra i proprietari, i commercianti e chi esercitava le professioni forensi. L’attività di queste Congregazioni di carità portava ad una perdita d’autonomia degli enti assistenziali non avendo più un proprio organismo d’amministrazione, trovandosi a dipendere dalla Congregazione[10].
Erano distribuite in tutto il territorio della Penisola ma in gran parte localizzate nelle regioni del Nord. Sono stati individuati vari modelli autonomi, i maggiori dei quali erano quello Piemontese, quello del Ducato di Modena, del Ducato di Parma, della Toscana, dello Stato Pontificio ed uno del Regno delle Due Sicilie. Il ruolo statale era contenuto, e le istituzioni di beneficenza erano pubbliche, nel senso di “aperte al pubblico, accessibili a tutti, non riservate”. Lo Stato non “assisteva” direttamente, limitandosi a garantire il buon funzionamento e la sorveglianza della consistenza patrimoniale delle Opere Pie[11].
Con la Gran Legge n.753/1862, si arrivò ad una forma unitaria alla disciplina delle Opere Pie che per trent’anni vide confrontarsi orientamenti diversi, ossia scuole di pensiero come il liberalismo moderato, la sinistra democratica ed il cattolicesimo sociale. I giudizi furono, ovviamente, molto diversi ma unanimemente la legge rappresentò un primo tentativo di istituzionalizzazione del Terzo settore su tutto il territorio nazionale al di fuori di indebite ingerenze governative[12]. La legge si proponeva due scopi: unificare la legislazione italiana sulle Opere Pie e di beneficenza ed emanciparle dall’ingerenza governativa, affidandole a loro stesse, fidando nella libertà[13].
Unità e libertà erano i principi ispiratori di questa prima soluzione legislativa, condivisa da moderati e cattolici, ma ritenuta contraddittoria dalle correnti di sinistra, che sostenevano che la beneficenza privata non poteva che produrre forme di patronage familiare. L’art.1 della Gran Legge definì le organizzazioni sottoposte alla legge stessa, che si individuavano “negli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi Ente morale avente in tutto od in parte il fine di soccorrere le classi meno agiate e prestare loro assistenza”. Ogni Opera Pia era sottoposta al controllo della relativa Deputazione Provinciale a cui doveva trasmettere tutta una serie di atti per l’approvazione. L’intento perseguito dal legislatore era stato indirizzato in varie direzioni: quello di varare un sistema basato sul disimpegno della finanza pubblica, che non generava diritti a favore di coloro che necessitavano dell’assistenza; quello dell’indipendenza degli istituti; quello della debole ingerenza governativa, con i ristretti limiti di controllo provinciale. Ma in seguito la disciplina del 1862 si rivelò un fallimento, rappresentato dall’insufficienza dei controlli e dalle responsabilità gravi dei soggetti interessati: il Ministero dell’Interno non esercitava la vigilanza, le Deputazioni Provinciali non assicuravano la tutela ed i Comuni erano restii nel proporre le trasformazioni pur previste dalla Legge. Si riscontrava, una forte sperequazione fra aree geografiche diverse, a sfavore di quelle Meridionali e delle Isole. I compartimenti settentrionali del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e del Veneto detenevano una consistenza patrimoniale di gran lunga maggiore rispetto alla situazione del Mezzogiorno dove, in alcune aree, c’erano, oltre che drammatiche carenze di risorse, anche mancanza di interventi di organizzazione sociale. Vennero alla luce gravi problemi amministrativi, sperequazioni di vario tipo, eccessiva incidenza delle spese di gestione in un periodo segnato da una grave crisi economica.
Nel 1890 fu approvata la legge n. 6972/1890, nota come Legge Crispi, che stabiliva che tutti gli Enti privati, finalizzati a prestare assistenza, dovessero assumere la veste giuridica di “Istituzioni pubbliche di beneficenza”, ovvero trasformarsi in enti pubblici con regole minuziose sull’assetto organizzativo e amministrativo, la gestione dei patrimoni, la contabilità e la tutela della vigilanza da parte dei pubblici poteri.
L’art 1, definendo le Opere Pie, “Istituzioni pubbliche di beneficenza”, non prevedeva per esse la possibilità di mantenere una natura privata o ecclesiastica, escludendo dalle stesse soltanto i Comitati di Soccorso e le fondazioni private, cosicché l’insieme del Terzo settore, nella sua varietà e ricchezza, veniva ricondotto ad una sola figura giuridica, almeno fino alla Costituzione Repubblicana. Si trattava di un azione nuova per l’epoca, poiché lo Stato entrava con la propria autorità in qualsiasi campo, anche in quello della beneficenza, fino ad allora quasi estraneo all’azione pubblica, gestito esclusivamente dalle attività caritatevoli della Chiesa cattolica e dalla libera iniziativa di cittadini filantropi.
La Legge Crispi rappresentava una forma di controllo e di disciplina uniforme dello Stato sulla beneficenza privata, con cui lo Stato non affermava una responsabilità diretta del potere pubblico nella garanzia del bisogno economico sociale dei più disagiati, ma consentiva la sottrazione delle Opere Pie al controllo della Chiesa Cattolica e permetteva di estendere i controlli anche su detti organismi cui lo Stato liberale guardava con diffidenza. Il ridimensionamento del potere della Chiesa fu drastico, con l’esclusione dei parroci dalla composizione delle Congregazioni di carità istituite in ogni Comune, che accrescevano il proprio ruolo rappresentando il centro propulsore dell’attività assistenziale a livello locale.
Legge Crispi rappresentava una forma di controllo e di disciplina uniforme dello Stato sulla beneficenza privata, con cui lo Stato non affermava una responsabilità diretta del potere pubblico nella garanzia del bisogno economico sociale dei più disagiati, ma consentiva la sottrazione delle Opere Pie al controllo della Chiesa Cattolica e permetteva di estendere i controlli anche su detti organismi cui lo Stato liberale guardava con diffidenza. Il ridimensionamento del potere della Chiesa fu drastico, con l’esclusione dei parroci dalla composizione delle Congregazioni di carità istituite in ogni Comune, che accrescevano il proprio ruolo rappresentando il centro propulsore dell’attività assistenziale a livello locale.
Altro elemento importante della riforma fu quello che imponeva un raggruppamento delle Opere Pie elemosiniere nella Congregazione di carità, chiamata ad amministrarne i patrimoni. Quanto agli effetti della legge sulla libertà dei cittadini, la trasformazione in Istituzioni pubbliche di beneficenza di enti e organizzazioni private compresse fortemente i diritti di libertà associativa. I cambiamenti e le trasformazioni che la riforma Crispina imponeva richiedevano una vigilanza costante sugli Enti nei rispettivi territori tanto che, negli anni successivi all’entrata in vigore, la sua applicazione procedette in modo blando, soprattutto per l’opposizione della Chiesa. Nell’opinione pubblica non si accettava, il radicalismo che aveva portato all’abolizione delle fondazioni di culto e all’esclusione dei parroci dalle Congregazioni di carità, “vera offesa” alla libertà e all’eguaglianza. La Legge Crispi è rimasta in vigore per oltre un secolo, essendo stata formalmente abrogata soltanto dalla legge n. 328/2000, “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”[14]. 
Bibliografia
[1] Kendal J. – Knapp M. “The voluntary sector in the U.K.”, Manchester United Press, 1992, Manchester UK.
[2] Zardin D. “Corpi fraternità e mestieri nella storia della società europea”, Roma, Bulzoni.
[3] Cherubini A. “Storia della previdenza sociale in ltalia”, Ed. Riunite, Roma.
[4] Levra U. “L’altro volto di Torino risorgimentale 1814–1848”, Torino, 1988.
[5] Zamagni V. “Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi”, Bologna, Il Mulino, 2000.
[6] Guenzi A. – Massa P. – Moioli A. “Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna”, Milano, F.Angeli,1999.
[7] Bressan E. “Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica”, Milano, Cariplo Laterza, 1985.
[8] Woolf S.J. “Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna”, Roma – Bari, Laterza, 1988.
[9] Silvano G. “Origini e sviluppi del Terzo settore italiano”, in “Società e Terzo settore. La vita italiana”, Bologna, Il Mulino, 2011.
[10] Piccialuti Caprioli M. “Opere pie e beneficenza pubblica: aspetti della legislazione piemontese da Carlo Alberto all’unificazione”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico n. 3, 1980.
[11] Silei G. “Lo Stato sociale in Italia. Storia e documenti”, vol. I°, Bari – Roma, P.L. 2003.
[12] Villari P. “La riforma della beneficenza” in Scritti sulla questione sociale in Italia, Firenze, 1902.
[13] De Siervo U. “Le trasformazioni della legislazione in tema di IPAB”, in “Giurisprudenza Costituzionale” I 1985.
[14] Pastori G. “Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000”, Giuffrè, Milano.
[*] Funzionario Area Amministrativa e Giuridico – Contenzioso in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per la relativa Amministrazione di appartenenza.



Seguiteci su Facebook