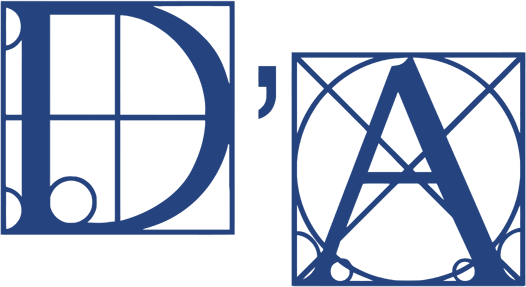
Lo stato delle relazioni industriali nei due livelli di contrattazione
Rappresentanza e rappresentatività dei soggetti contraenti nel settore privato
di Marco Biagiotti [*]
 Ha suscitato scalpore un recente report pubblicato dal CNEL sul proprio sito istituzionale che certifica l’esistenza, in Italia, di 868 contratti collettivi nazionali di lavoro (dati aggiornati al 30 settembre scorso) distribuiti fra i vari settori produttivi. L’analisi di dettaglio è impressionante: nel settore dell’Agricoltura, ad esempio, sono censiti 49 accordi nazionali vigenti, 34 nei Chimici, 31 nei Meccanici, 39 negli Alimentaristi/Agroindustriali, 68 nell’Edilizia, 65 nei Trasporti, 31 nel Credito/Assicurazioni, 42 nei Servizi, addirittura 213 nel Commercio... Se questo è lo stato dell’arte delle relazioni industriali nel nostro Paese, c'è di che porsi qualche seria domanda sulla direzione verso cui esse stanno evolvendo, almeno per quanto riguarda le evidenze disponibili sulla contrattazione di primo livello. Certo, occorre tener conto del fatto che il report viene compilato secondo una logica che riflette la mission onnicomprensiva dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, istituito oltre 30 anni fa e tenuto – per esplicita previsione normativa – ad acquisire, conservare e rendere disponibili alla pubblica consultazione tutti gli accordi di contrattazione collettiva ivi depositati a cura delle parti stipulanti. L’elenco dei contratti nazionali classificati come “vigenti” potrebbe essere sfrondato adottando criteri più selettivi, a seconda delle finalità delle indagini che si vogliono compiere o dei fenomeni che si vogliono mettere in evidenza. Ad esempio, si potrebbero togliere tutti i contratti ‘dinosauro’ (quelli, cioè, che risultano non rinnovati da molti anni, magari perché nel frattempo sono confluiti in altri contratti nazionali), gli accordi di adesione successiva da parte di altre sigle sindacali ad un CCNL capofila, oppure i semplici verbali integrativi di precedenti accordi nazionali: tutte operazioni non particolarmente difficili da compiere, sulla base delle informazioni già contenute nel report stesso; ma il numero totale resterebbe pur sempre alto[1]. E anche ammettendo che la classificazione di cui sopra sia effettuata per comparti molto aggregati e che, ai fini di un’indagine più accurata, essi potrebbero forse essere articolati in un numero maggiore di settori produttivi (magari facendo riferimento ai codici di classificazione professionale ATECO, oppure distinguendo con più precisione gli accordi in base alle categorie dimensionali delle aziende), resta la chiara percezione di un mondo del lavoro estremamente sfrangiato e disperso, come forse mai era accaduto nella storia economica e sociale dell’Italia negli ultimi decenni. Le conseguenze di questa tendenza in atto nel sistema relazionale, in verità, non sono del tutto chiare, anche perché si tratta di un fenomeno in rapida crescita e ancora relativamente poco esplorato. Occorrerebbe una lettura sistematica e comparativa di tutti i contratti collettivi nazionali vigenti in ciascun settore produttivo[2] per rendersi conto se e dove passi, eventualmente, la sottile linea rossa che divide il pluralismo contrattuale da quel territorio Comanche della democrazia economica in cui il disvalore del lavoro preannuncia e, in qualche misura, configura i segni inequivocabili del dumping. Per adesso, quindi, accontentiamoci degli elementi che è possibile mettere insieme sulla scorta di un’analisi empirica e meramente ricognitiva del materiale disponibile.
Ha suscitato scalpore un recente report pubblicato dal CNEL sul proprio sito istituzionale che certifica l’esistenza, in Italia, di 868 contratti collettivi nazionali di lavoro (dati aggiornati al 30 settembre scorso) distribuiti fra i vari settori produttivi. L’analisi di dettaglio è impressionante: nel settore dell’Agricoltura, ad esempio, sono censiti 49 accordi nazionali vigenti, 34 nei Chimici, 31 nei Meccanici, 39 negli Alimentaristi/Agroindustriali, 68 nell’Edilizia, 65 nei Trasporti, 31 nel Credito/Assicurazioni, 42 nei Servizi, addirittura 213 nel Commercio... Se questo è lo stato dell’arte delle relazioni industriali nel nostro Paese, c'è di che porsi qualche seria domanda sulla direzione verso cui esse stanno evolvendo, almeno per quanto riguarda le evidenze disponibili sulla contrattazione di primo livello. Certo, occorre tener conto del fatto che il report viene compilato secondo una logica che riflette la mission onnicomprensiva dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, istituito oltre 30 anni fa e tenuto – per esplicita previsione normativa – ad acquisire, conservare e rendere disponibili alla pubblica consultazione tutti gli accordi di contrattazione collettiva ivi depositati a cura delle parti stipulanti. L’elenco dei contratti nazionali classificati come “vigenti” potrebbe essere sfrondato adottando criteri più selettivi, a seconda delle finalità delle indagini che si vogliono compiere o dei fenomeni che si vogliono mettere in evidenza. Ad esempio, si potrebbero togliere tutti i contratti ‘dinosauro’ (quelli, cioè, che risultano non rinnovati da molti anni, magari perché nel frattempo sono confluiti in altri contratti nazionali), gli accordi di adesione successiva da parte di altre sigle sindacali ad un CCNL capofila, oppure i semplici verbali integrativi di precedenti accordi nazionali: tutte operazioni non particolarmente difficili da compiere, sulla base delle informazioni già contenute nel report stesso; ma il numero totale resterebbe pur sempre alto[1]. E anche ammettendo che la classificazione di cui sopra sia effettuata per comparti molto aggregati e che, ai fini di un’indagine più accurata, essi potrebbero forse essere articolati in un numero maggiore di settori produttivi (magari facendo riferimento ai codici di classificazione professionale ATECO, oppure distinguendo con più precisione gli accordi in base alle categorie dimensionali delle aziende), resta la chiara percezione di un mondo del lavoro estremamente sfrangiato e disperso, come forse mai era accaduto nella storia economica e sociale dell’Italia negli ultimi decenni. Le conseguenze di questa tendenza in atto nel sistema relazionale, in verità, non sono del tutto chiare, anche perché si tratta di un fenomeno in rapida crescita e ancora relativamente poco esplorato. Occorrerebbe una lettura sistematica e comparativa di tutti i contratti collettivi nazionali vigenti in ciascun settore produttivo[2] per rendersi conto se e dove passi, eventualmente, la sottile linea rossa che divide il pluralismo contrattuale da quel territorio Comanche della democrazia economica in cui il disvalore del lavoro preannuncia e, in qualche misura, configura i segni inequivocabili del dumping. Per adesso, quindi, accontentiamoci degli elementi che è possibile mettere insieme sulla scorta di un’analisi empirica e meramente ricognitiva del materiale disponibile.
Il primo elemento che colpisce è che solo una minima parte dei CCNL censiti risultano essere stati siglati dalle tradizionali grandi organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro. Molti accordi nazionali portano la firma di sindacati poco noti al grande pubblico e, talvolta, presentano caratteristiche di multisettorialità che li rendono applicabili trasversalmente a più ambiti produttivi, i cui criteri di assemblaggio andrebbero peraltro verificati in termini di coerenza e funzionalità rispetto ai pur flessibili confini dei vari mercati del lavoro esistenti a livello di territorio, di distretto o di filiera. Qualcuno l’ha definita una vera e propria giungla[3], nella quale si moltiplicano i soggetti rappresentativi che rivendicano la portata nazionale dei propri accordi. Dai quali, beninteso, possono discendere decine (se non centinaia) di accordi di secondo livello presso le imprese che aderiscono alle associazioni nazionali firmatarie o che, più semplicemente, dichiarano di aderire ad accordi da quelle sottoscritti. D’altra parte, gli interventi normativi susseguitisi negli ultimi anni in materia di politiche del lavoro hanno assegnato un ruolo sempre più rilevante al sistema delle relazioni industriali, delegando ad esso – in modo esplicito o implicito – l’attuazione di pezzi importantissimi delle varie riforme messe in campo. Con annessa distribuzione – vedi il caso della defiscalizzazione dei premi di produttività e/o delle prestazioni di welfare aziendale – a lavoratori e imprese di cospicui finanziamenti a carico dell’intera collettività. Bastano queste semplici considerazioni per comprendere come sia divenuto ormai non più solo opportuno, ma forse addirittura necessario e persino urgente giungere alla definizione di criteri oggettivi per misurare la reale rappresentatività delle associazioni che firmano gli accordi nazionali e di secondo livello, anche al fine di evitare, da un lato, il rischio di dumping sociale a danno dei lavoratori e, dall’altro, quello di concorrenza sleale fra imprese che operano nello stesso settore produttivo.
Come è ben noto da circa 25 anni ai grandi sindacati confederali e alle grandi associazioni datoriali, la misurazione della rappresentatività dei soggetti che firmano gli accordi nazionali è un’operazione complicata, non solo per motivi tecnici. Per adesso si è riusciti ad attuarla solo nella pubblica amministrazione, dove dal 1998 viene regolarmente misurata e certificata ogni tre anni la percentuale di rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi nazionali; e dove solo quelle che raggiungono la soglia del 5% su base nazionale vengono ammesse alle trattative per i rinnovi dei CCNL. Ma la p.a. è un universo chiuso, stabile e consolidato, regolato da norme e leggi ad hoc e sostenuto da un apparato burocratico che funziona per procedure ed adempimenti, la cui mancata attuazione comporta precise responsabilità amministrative e disciplinari a carico di dirigenti e funzionari incaricati. Nulla a che vedere con il mondo del lavoro privato, che in Italia è formato da una sterminata galassia di circa 4,3 milioni di imprese grandi, medie, piccole e piccolissime, impegnate in una quotidiana lotta per la sopravvivenza ed alla continua ricerca di nuovi assetti e strategie tramite fusioni, scorpori, cessione di rami, acquisizioni, trasferimenti, revisioni organizzative… l’immagine stessa del cambiamento e della trasformazione continua. Come misurare, allora, ciò che per sua stessa natura (e per le leggi del mercato) muta incessantemente?
La soluzione sembrava l’avessero trovata Confindustria, Cgil, Cisl e Uil quando, dopo un percorso di progressiva convergenza durato diversi anni, il 10 gennaio 2014 firmarono insieme il Testo Unico sulla Rappresentanza, ossia una procedura per ‘pesare’ le organizzazioni sindacali ai fini della validità degli accordi nazionali del settore privato. In estrema sintesi, la procedura (che con protocolli successivi è stata estesa a quasi tutti i principali settori del mondo produttivo e ha visto l’adesione di altre importanti confederazioni sindacali e datoriali) prevede che la rappresentatività sindacale venga determinata a livello nazionale calcolando, settore per settore, la media ponderata fra il numero degli iscritti a ciascun sindacato e il numero dei voti riportati da ciascuna lista sindacale nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) effettuate in ogni singola unità produttiva a suffragio universale fra tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un’organizzazione sindacale. A grandi linee, il meccanismo ricalca quello già applicato nel settore pubblico, ma con alcune differenze fondamentali. La prima è che nel pubblico le elezioni per le RSU sono obbligatorie e si tengono per legge ogni tre anni, mentre nel privato non esiste l'obbligo per le aziende di costituire, al proprio interno, queste forme di rappresentanza; quindi, in molte imprese esse non sono mai state elette, né forse lo saranno mai. Anzi, nella maggior parte delle imprese di piccole dimensioni, che in Italia sono più del 90%, non è presente alcuna forma di rappresentanza sindacale, per cui non avviene alcun tipo di contrattazione di secondo livello e l’applicazione delle norme sullo sgravio fiscale del salario di produttività e del welfare contrattuale avviene a seguito di formale e spontanea adesione delle imprese ad altri accordi già stipulati a livello territoriale. D’altronde, anche fra le grandi aziende esistono sensibilità alquanto diverse sul tema della scelta delle rappresentanze interne, come dimostra, uber alles, il caso Fiat (ora FCA), in cui le rappresentanze sindacali che firmano gli accordi nazionali e a livello di unità produttiva vengono scelte dai lavoratori (e fra i lavoratori) con criteri che non seguono affatto le indicazioni del Testo Unico del 10-1-2014[4].
 La seconda differenza è che nel pubblico la rilevazione del dato associativo e di quello elettorale, dalla cui media ponderata si ricava, appunto, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, viene effettuata a cura (e sotto la responsabilità) della macchina amministrativa, con procedure definite nei minimi dettagli e scandite da precise scadenze temporali. I datori di lavoro privati, viceversa, comunicano all’INPS (peraltro non obbligatoriamente) il numero delle deleghe alle varie associazioni sindacali risultanti in ogni unità produttiva, mentre il compito di rilevare i numero dei voti ottenuti nelle elezioni per le RSU (parliamo ovviamente delle aziende dove le elezioni vengono effettuate, che non sono certo la totalità) è affidato, in ogni territorio e per ciascun settore di applicazione dei CCNL, a una apposita commissione - il Comitato dei garanti – da costituire ad hoc presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro, nel frattempo transitati sotto l’egida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Secondo le previsioni del Testo Unico, la media ponderata delle due rilevazioni per il settore privato, nonché la successiva certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della validità degli accordi nazionali di contrattazione collettiva, spetterebbe al CNEL[5], che dovrebbe a tal fine ricevere i dati dagli altri due enti previa stipula di apposite convenzioni operative: un sistema, come si vede, nettamente più complesso e dispersivo di quello adottato per la p.a., difficile da far funzionare (infatti finora non ha mai funzionato) senza che vi sia uno stretto coordinamento strategico-politico, oltre che tecnico e operativo, fra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
La seconda differenza è che nel pubblico la rilevazione del dato associativo e di quello elettorale, dalla cui media ponderata si ricava, appunto, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, viene effettuata a cura (e sotto la responsabilità) della macchina amministrativa, con procedure definite nei minimi dettagli e scandite da precise scadenze temporali. I datori di lavoro privati, viceversa, comunicano all’INPS (peraltro non obbligatoriamente) il numero delle deleghe alle varie associazioni sindacali risultanti in ogni unità produttiva, mentre il compito di rilevare i numero dei voti ottenuti nelle elezioni per le RSU (parliamo ovviamente delle aziende dove le elezioni vengono effettuate, che non sono certo la totalità) è affidato, in ogni territorio e per ciascun settore di applicazione dei CCNL, a una apposita commissione - il Comitato dei garanti – da costituire ad hoc presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro, nel frattempo transitati sotto l’egida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Secondo le previsioni del Testo Unico, la media ponderata delle due rilevazioni per il settore privato, nonché la successiva certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della validità degli accordi nazionali di contrattazione collettiva, spetterebbe al CNEL[5], che dovrebbe a tal fine ricevere i dati dagli altri due enti previa stipula di apposite convenzioni operative: un sistema, come si vede, nettamente più complesso e dispersivo di quello adottato per la p.a., difficile da far funzionare (infatti finora non ha mai funzionato) senza che vi sia uno stretto coordinamento strategico-politico, oltre che tecnico e operativo, fra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
A queste differenze, poi, se ne aggiunge una terza, forse ancora più determinante delle altre due: nel pubblico gli accordi sindacali, nazionali e decentrati, si fanno con un datore di lavoro (la pubblica amministrazione) che non ha bisogno di essere ‘misurato’, dal momento che rappresenta l’interesse generale della collettività e, pertanto, non compete con altri soggetti datoriali omologhi per natura e funzioni; nel mondo delle imprese gli accordi nazionali recano la firma delle organizzazioni (private) dei lavoratori e delle organizzazioni (private) dei datori di lavoro: ma il meccanismo di misurazione della rappresentatività escogitato nel Testo Unico del 10-1-2014 riguarda solo le prime. Chi garantisce che anche il datore di lavoro privato firmatario di un determinato accordo nazionale di categoria sia effettivamente rappresentativo in quel settore? Allo stato attuale, nessuno. E questa è una delle ragioni principali (non l’unica, certo) che sta alla radice dell’impressionante sequela dei quasi 900 contratti collettivi nazionali oggi esistenti in Italia. Senza voler comprimere la libertà di associazione costituzionalmente tutelata, sono forse maturi i tempi per cominciare ad introdurre qualche elemento di oggettività che consenta di risalire quanto meno al numero di imprese che aderiscono ad una certa associazione imprenditoriale, al numero di addetti coinvolti su base nazionale, al peso del loro fatturato nei settori produttivi dove sono presenti. Analogamente, occorrerebbe poter conoscere con sufficiente approssimazione il numero di lavoratori iscritti ad un certo sindacato, le caratteristiche della sua struttura organizzativa, l’effettiva portata degli accordi sottoscritti in termini di ampiezza della platea di destinatari.
 Nella situazione attuale, è impossibile impedire a qualunque associazione di auto-definirsi rappresentativa e di concludere accordi ‘nazionali’ negli stessi settori già coperti dagli accordi ‘nazionali’ firmati da altre organizzazioni concorrenti, i quali risultano magari meno vantaggiosi per le imprese che vi aderiscono. Del resto, per i datori di lavoro privati non esiste alcun obbligo di applicare, nella propria azienda, un determinato CCNL piuttosto che un altro. Tanto meno esistono, per le associazioni sindacali del settore privato, norme che stabiliscano soglie minime di rappresentatività (come invece avviene nel settore pubblico) ai fini della validità degli accordi collettivi nazionali. E se consideriamo che attraverso gli accordi collettivi è possibile disciplinare una quantità enorme di aspetti che riguardano la produttività, la qualità e l’organizzazione del lavoro, oltre a quelli di carattere meramente retributivo, si comprende come la concorrenza fra i diversi CCNL (e, quindi, fra le varie associazioni di categoria che si auto-accreditano come “nazionali”) si stia facendo sempre più serrata: non solo all’interno dei settori produttivi, ma soprattutto nelle zone di confine – spesso incerto – fra un settore e l’altro. Qualche esempio illuminante si può trovare spulciando nella galassia di CCNL che rientra sotto le denominazioni Terziario, Distribuzione e Servizi, all’interno dell’aggregato “Commercio”, nei report CNEL di cui si parlava in apertura[6]. Mentre si avvia a regime la ‘pesatura’ delle rappresentatività sindacali ai fini della validità degli accordi, occorrerebbe forse anche immaginare l’istituzione di un registro ufficiale delle associazioni rappresentative nel settore privato ai fini negoziali, attraverso il quale ciascuna organizzazione renda pubblica ed evidente, secondo criteri di piena trasparenza, le informazioni sulla propria struttura organizzativa, sulla propria consistenza associativa, sulla propria attività e sui settori produttivi di riferimento. Cosa si dovrebbe pensare di un accordo collettivo che si autodefinisca ‘nazionale’, ma che risulti firmato (si tratta ovviamente di una pura ipotesi) da un’associazione datoriale e da una sindacale le cui rispettive sedi risultino collocate nello stesso condominio, o nei cui rispettivi organigrammi si incontrino dirigenti che portano lo stesso cognome?
Nella situazione attuale, è impossibile impedire a qualunque associazione di auto-definirsi rappresentativa e di concludere accordi ‘nazionali’ negli stessi settori già coperti dagli accordi ‘nazionali’ firmati da altre organizzazioni concorrenti, i quali risultano magari meno vantaggiosi per le imprese che vi aderiscono. Del resto, per i datori di lavoro privati non esiste alcun obbligo di applicare, nella propria azienda, un determinato CCNL piuttosto che un altro. Tanto meno esistono, per le associazioni sindacali del settore privato, norme che stabiliscano soglie minime di rappresentatività (come invece avviene nel settore pubblico) ai fini della validità degli accordi collettivi nazionali. E se consideriamo che attraverso gli accordi collettivi è possibile disciplinare una quantità enorme di aspetti che riguardano la produttività, la qualità e l’organizzazione del lavoro, oltre a quelli di carattere meramente retributivo, si comprende come la concorrenza fra i diversi CCNL (e, quindi, fra le varie associazioni di categoria che si auto-accreditano come “nazionali”) si stia facendo sempre più serrata: non solo all’interno dei settori produttivi, ma soprattutto nelle zone di confine – spesso incerto – fra un settore e l’altro. Qualche esempio illuminante si può trovare spulciando nella galassia di CCNL che rientra sotto le denominazioni Terziario, Distribuzione e Servizi, all’interno dell’aggregato “Commercio”, nei report CNEL di cui si parlava in apertura[6]. Mentre si avvia a regime la ‘pesatura’ delle rappresentatività sindacali ai fini della validità degli accordi, occorrerebbe forse anche immaginare l’istituzione di un registro ufficiale delle associazioni rappresentative nel settore privato ai fini negoziali, attraverso il quale ciascuna organizzazione renda pubblica ed evidente, secondo criteri di piena trasparenza, le informazioni sulla propria struttura organizzativa, sulla propria consistenza associativa, sulla propria attività e sui settori produttivi di riferimento. Cosa si dovrebbe pensare di un accordo collettivo che si autodefinisca ‘nazionale’, ma che risulti firmato (si tratta ovviamente di una pura ipotesi) da un’associazione datoriale e da una sindacale le cui rispettive sedi risultino collocate nello stesso condominio, o nei cui rispettivi organigrammi si incontrino dirigenti che portano lo stesso cognome?
 Ma il problema non riguarda, ovviamente, solo il livello nazionale della contrattazione. Se i circa 900 accordi nazionali oggi esistenti costituiscono un giacimento di notizie ancora poco note, le migliaia e migliaia di accordi di secondo livello conclusi ogni anno nelle nostre imprese e nei territori rappresentano un campo d’indagine pressoché inesplorato. La progressiva crescita di importanza della contrattazione di secondo livello sta trasformando dal profondo il sistema delle relazioni industriali e, in misura non trascurabile e per quanto ad essa riconducibili, gli stessi criteri di organizzazione del lavoro nelle imprese. L’applicazione di alcuni istituti di rilevante importanza economica e sociale, come la detassazione dei premi di produttività e/o del welfare aziendale, è strettamente vincolata alle previsioni della contrattazione collettiva integrativa, aziendale o territoriale. Ora, dal momento che, secondo le disposizioni introdotte dalla legge 208/2015, queste agevolazioni fiscali dovrebbero essere collegate ad incrementi di redditività e di produttività delle nostre imprese e, quindi, finalizzate ad accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, appare necessario organizzare meglio la conoscenza dei contenuti di questi accordi e – per restare al tema del nostro discorso – avere un quadro il più dettagliato ed aggiornato possibile delle organizzazioni (datoriali e sindacali) che li sottoscrivono[7] .
Ma il problema non riguarda, ovviamente, solo il livello nazionale della contrattazione. Se i circa 900 accordi nazionali oggi esistenti costituiscono un giacimento di notizie ancora poco note, le migliaia e migliaia di accordi di secondo livello conclusi ogni anno nelle nostre imprese e nei territori rappresentano un campo d’indagine pressoché inesplorato. La progressiva crescita di importanza della contrattazione di secondo livello sta trasformando dal profondo il sistema delle relazioni industriali e, in misura non trascurabile e per quanto ad essa riconducibili, gli stessi criteri di organizzazione del lavoro nelle imprese. L’applicazione di alcuni istituti di rilevante importanza economica e sociale, come la detassazione dei premi di produttività e/o del welfare aziendale, è strettamente vincolata alle previsioni della contrattazione collettiva integrativa, aziendale o territoriale. Ora, dal momento che, secondo le disposizioni introdotte dalla legge 208/2015, queste agevolazioni fiscali dovrebbero essere collegate ad incrementi di redditività e di produttività delle nostre imprese e, quindi, finalizzate ad accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, appare necessario organizzare meglio la conoscenza dei contenuti di questi accordi e – per restare al tema del nostro discorso – avere un quadro il più dettagliato ed aggiornato possibile delle organizzazioni (datoriali e sindacali) che li sottoscrivono[7] .
A parte le indagini campionarie pubblicate dai centri studi sindacali o da qualche istituto di ricerca specializzato, la fonte più completa ed attendibile di informazioni è rappresentata dai report periodici del Ministero del lavoro sui contratti aziendali e territoriali depositati ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016, ai sensi del decreto interministeriale Lavoro-Economia 25 marzo 2016. Il più recente di tali report, rilasciato il 15 dicembre scorso, informa che, a partire dall’inizio della procedura di deposito obbligatorio (luglio 2016) sono stati inviati telematicamente agli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 28.515 accordi territoriali e aziendali, di cui 15.639 risultano “ancora attivi”.
 Le informative ministeriali, ancorché succinte, permettono di ricavare notizie preziose sul rapporto numerico tra accordi aziendali e territoriali (ad esempio, si nota che oltre l’80% degli accordi classificati come “attivi” è di tipo aziendale), sulla loro distribuzione geografica (circa il 70% del totale degli accordi depositati si riferisce a regioni del Nord), sull’incidenza dei contenuti legati a temi per i quali la legge prevede lo sconto fiscale sui premi di produttività (su 15.639 accordi “attivi”, 12.269 contengono clausole concernenti il raggiungimento di obiettivi di produttività, 9.033 di redditività, 7.302 di qualità, 5.236 prevedono misure di welfare aziendale e solo 2.039 prevedono un piano di partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’azienda). Ma sarebbe interessante poter disporre, in futuro, di qualche riscontro più preciso anche sui settori produttivi nei quali maggiormente vengono conclusi questi accordi, sul numero e sull’identità dei soggetti che li sottoscrivono, sull’entità dei premi corrisposti in relazione al settore produttivo e al dimensionamento aziendale. In effetti, negli ultimi tempi iniziano a diventare più frequenti i tentativi di analizzare in modo più sistematico la cospicua massa informativa sulla contrattazione di secondo livello, passando al setaccio i testi degli accordi disponibili per provare a comprendere meglio che cosa stia realmente accadendo dentro le nostre aziende e come si stia realmente trasformando il nostro mercato del lavoro. Piace qui ricordare, innanzitutto, lo sforzo compiuto dalla Fondazione D'Antona nel promuovere e curare l'edizione del prezioso volume sulla contrattazione collettiva aziendale in chiave di comparazione internazionale presentato il 13 dicembre scorso[8].
Le informative ministeriali, ancorché succinte, permettono di ricavare notizie preziose sul rapporto numerico tra accordi aziendali e territoriali (ad esempio, si nota che oltre l’80% degli accordi classificati come “attivi” è di tipo aziendale), sulla loro distribuzione geografica (circa il 70% del totale degli accordi depositati si riferisce a regioni del Nord), sull’incidenza dei contenuti legati a temi per i quali la legge prevede lo sconto fiscale sui premi di produttività (su 15.639 accordi “attivi”, 12.269 contengono clausole concernenti il raggiungimento di obiettivi di produttività, 9.033 di redditività, 7.302 di qualità, 5.236 prevedono misure di welfare aziendale e solo 2.039 prevedono un piano di partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’azienda). Ma sarebbe interessante poter disporre, in futuro, di qualche riscontro più preciso anche sui settori produttivi nei quali maggiormente vengono conclusi questi accordi, sul numero e sull’identità dei soggetti che li sottoscrivono, sull’entità dei premi corrisposti in relazione al settore produttivo e al dimensionamento aziendale. In effetti, negli ultimi tempi iniziano a diventare più frequenti i tentativi di analizzare in modo più sistematico la cospicua massa informativa sulla contrattazione di secondo livello, passando al setaccio i testi degli accordi disponibili per provare a comprendere meglio che cosa stia realmente accadendo dentro le nostre aziende e come si stia realmente trasformando il nostro mercato del lavoro. Piace qui ricordare, innanzitutto, lo sforzo compiuto dalla Fondazione D'Antona nel promuovere e curare l'edizione del prezioso volume sulla contrattazione collettiva aziendale in chiave di comparazione internazionale presentato il 13 dicembre scorso[8].
Indagini sulla base dei dati ricavati dal monitoraggio delle dichiarazioni di conformità allegate al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, ai fini delle agevolazioni sui premi di produttività, sono in corso di elaborazione da parte dell'INAPP, mentre si affacciano nuove ricerche condotte su basi campionarie sempre più ampie e qualificate, aventi per oggetto i contenuti degli accordi decentrati, aziendali e territoriali, conclusi nelle aziende del settore privato[9]. Ma siamo appena agli inizi di un percorso di sistemazione delle conoscenze che non sarà certo facile, né breve, stante una certa difficoltà nel reperire in modo estensivo i testi aggiornati degli accordi sottoscritti, anche per via della scarsa propensione dei soggetti firmatari a renderne pubblico l’accesso. Ma forse il vero salto culturale spetta alle istituzioni pubbliche che, in vario grado e per diverse finalità, sono interessate all’analisi dello sviluppo e delle tendenze delle relazioni industriali. Superando vecchie logiche autoreferenziali che oggi non appaiono più compatibili con la complessità dei fenomeni in atto, le pubbliche amministrazioni (nazionali e locali) devono riuscire a trovare la capacità di operare in sinergia, mettendo a sistema le rispettive competenze istituzionali ed integrando i rispettivi data-base e i rispettivi know-how tecnico-operativi. Su questo terreno si gioca una delle sfide più difficili, ma anche più stimolanti per lo sviluppo del Paese nei prossimi decenni: quella, cioè, di realizzare un servizio pubblico in grado non solo di rendere evidenti e riconoscibili, ma di favorire l’adozione su vasta scala e ad ogni livello di buone e qualificanti prassi negoziali. ![]()
 Note
Note
[1] Secondo un recentissimo studio della Banca d’Italia, “al netto di quelli scaduti il numero dei CCNL presenti nell’Archivio CNEL si dimezzerebbe, rimanendo tuttavia estremamente elevato (373 nel settembre 2017)”. Vedi: “I recenti sviluppi delle relazioni industriali in Italia”, di Francesco D’Amuri e Raffaella Nizzi, in “Banca d’Italia – Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)” n. 416 – Dicembre 2017, pag. 9. Peraltro, al riguardo, sarebbe interessante poter avere qualche ragguaglio più preciso sui criteri adottati per selezionare i “contratti scaduti”, sino ad abbassare la quota dei vigenti a 373.
[2] Curiosamente, per quanto consta a chi scrive, una cosa del genere non è stata sinora mai nemmeno tentata: strana Incongruenza per un Paese che vanta decine di affermate cattedre universitarie in studi economici, giuridici, sociali e delle relazioni industriali, con supporto di relative pubblicazioni accademiche, più un numero imprecisato di centri di studio e di ricerca istituzionali, pubblici e privati, ma che fatica a trovare la giusta ispirazione per esplorare a fondo un data-base pubblico di straordinario interesse, continuamente aggiornato, facilmente e gratuitamente consultabile on-line da qualunque cittadino munito di una semplice connessione internet.
[3] “La giungla degli 868 contratti collettivi”, di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, in “Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi”, 9 novembre 2017.
[4] Vedi, al riguardo, la sezione “Diritti sindacali” del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) 7 luglio 2015, firmato, per la parte datoriale, da FCA e CNH Industrial e, per la parte sindacale, da FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici a dall'Associazione Quadri e Capi FIAT.
[5] Ma una recente modifica al Testo Unico, sottoscritta da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 4 luglio 2017, ha spostato tale incombenza sull’INPS, sebbene i soggetti firmatari di parte sindacale abbiano successivamente chiarito che si tratta di un passaggio di consegne provvisorio, in attesa che il CNEL – sopravvissuto alle note vicissitudini legate al tentativo di riforma costituzionale promosso dal precedente governo – completi il proprio processo di riforma e di riorganizzazione. Ad ogni modo, nel protocollo del 4 luglio 2017 Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno definito un calendario serrato di adempimenti che dovrebbe portare, nel 2019, al rilascio della prima certificazione effettiva in riferimento ai dati rilevati nell’anno precedente. Peraltro, anche in questo caso i problemi non sarebbero del tutto risolti, poiché molte associazioni datoriali e sindacali autonome (ne nascono come funghi da qualche anno a questa parte e un censimento ufficiale aggiornato non esiste) non hanno aderito all’accordo del 10 gennaio 2014, né si presume che avvertano una particolare urgenza di farlo. Ciò significa che la certificazione della rappresentatività sindacale (quella datoriale, per il momento, non è presa in considerazione), ove mai avvenisse, riguarderebbe solo le associazioni nazionali che abbiano formalmente aderito alle regole del Testo Unico. Le altre resterebbero libere di muoversi in base al semplice presupposto dell’autocertificazione della rappresentatività, continuando a firmare accordi pienamente legittimi in attesa che una legge del Parlamento intervenga, prima o poi, a stabilire regole uguali per tutti.
 [6] Anche il già ricordato studio della Banca d’Italia dedica significative riflessioni a questo aspetto del problema, in particolare nel paragrafo “La diffusione di CCNL stipulati da organizzazioni poco rappresentative”, dove, fra le altre cose, a proposito del settore Commercio si legge: “Solo per citare alcuni – rilevanti – esempi relativi a questo settore, nel 2011 si è assistito all’uscita dalla Confcommercio di Federdistribuzione, un’associazione cui attualmente aderiscono imprese che rappresentano circa la metà del fatturato della Grande Distribuzione Organizzata e occupano 200.000 addetti. Federdistribuzione continua al momento ad applicare il CCNL “Terziario distribuzione e servizi”, vigente al momento della sua separazione dalla Confcommercio e ora scaduto, non essendo ancora pervenuta alla stipula di un nuovo contratto di lavoro proprio, e non avendo aderito al successivo rinnovo del citato CCNL Terziario, che ha inizialmente previsto un aumento delle retribuzioni pari al 4 per cento nell’arco di 33 mesi. In altri casi sono stati stipulati nuovi CCNL da parte di organizzazioni minori, che prevedevano trattamenti retributivi inferiori, maggiore flessibilità di orario e nessun aumento retributivo nel periodo di vigenza. È questo il caso, ad esempio, del contratto CIFA-PMI del luglio 2013, che prevede, rispetto a quello Confcommercio, una mensilità in meno, un minimo dei minimi inferiore del 7 per cento circa, nessun aumento retributivo nel periodo di vigenza.” (“I recenti sviluppi delle relazioni industriali in Italia”, di Francesco D’Amuri e Raffaella Nizzi, cit., pag. 10).
[6] Anche il già ricordato studio della Banca d’Italia dedica significative riflessioni a questo aspetto del problema, in particolare nel paragrafo “La diffusione di CCNL stipulati da organizzazioni poco rappresentative”, dove, fra le altre cose, a proposito del settore Commercio si legge: “Solo per citare alcuni – rilevanti – esempi relativi a questo settore, nel 2011 si è assistito all’uscita dalla Confcommercio di Federdistribuzione, un’associazione cui attualmente aderiscono imprese che rappresentano circa la metà del fatturato della Grande Distribuzione Organizzata e occupano 200.000 addetti. Federdistribuzione continua al momento ad applicare il CCNL “Terziario distribuzione e servizi”, vigente al momento della sua separazione dalla Confcommercio e ora scaduto, non essendo ancora pervenuta alla stipula di un nuovo contratto di lavoro proprio, e non avendo aderito al successivo rinnovo del citato CCNL Terziario, che ha inizialmente previsto un aumento delle retribuzioni pari al 4 per cento nell’arco di 33 mesi. In altri casi sono stati stipulati nuovi CCNL da parte di organizzazioni minori, che prevedevano trattamenti retributivi inferiori, maggiore flessibilità di orario e nessun aumento retributivo nel periodo di vigenza. È questo il caso, ad esempio, del contratto CIFA-PMI del luglio 2013, che prevede, rispetto a quello Confcommercio, una mensilità in meno, un minimo dei minimi inferiore del 7 per cento circa, nessun aumento retributivo nel periodo di vigenza.” (“I recenti sviluppi delle relazioni industriali in Italia”, di Francesco D’Amuri e Raffaella Nizzi, cit., pag. 10).
[7] Estremamente interessanti appaiono, sotto questo ed altri profili, i riscontri desumibili dal III Rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva in Italia 2014-2016 (ADAPT, University Press, 2017), elaborati su una base campionaria di 370 contratti aziendali, ancorché selezionati con criteri non esclusivamente afferenti al tema della detassazione.
[8] Federica Minolfi “La contrattazione collettiva aziendale. L’ordinamento dell’Unione Europea e l’evoluzione comparata dell’istituto in Francia e in Italia”, Roma, Fondazione prof. Massimo D’Antona, 2017.
[9] Vedi: “Contrattazione integrativa e welfare aziendale: un’indagine empirica”, a cura di Claudio Lucifora (Università Cattolica/CNEL) e Federica Origo (Università di Bergamo), presentato il 6 dicembre u.s. al CNEL in occasione del convegno di presentazione del Rapporto su “Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2016-2017”, (in www.cnel.it/comunicazione/primo-piano) e che tiene conto anche di 2.094 accordi detenuti dall’Osservatorio OCSEL/CISL sulla contrattazione di secondo livello, nonché di un’indagine condotta da Federmeccanica nel 2015 e 2016 su circa 1.300 imprese del settore metalmeccanico.
Nel quadro dei contributi diffusi in occasione del ricordato convegno di cui sopra, si veda anche: “Welfare aziendale, organizzazione del lavoro, flessibilità degli orari, maternità e paternità: un’analisi qualitativa dei contratti”, realizzato a cura di Antonella Marsala e Fabiana Alias di ANPAL-Servizi, in: CNEL-INAPP-ANPAL, “Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2016-2017”, pp. 85-92 (www.cnel.it/rapporto_mercatodellavoro_contrattazione_2016-2017).
[*] Marco Biagiotti, già dipendente del Ministero del Lavoro, lavora presso il CNEL. In passato ha collaborato alla realizzazione, per la UIL Pubblica Amministrazione, della collana di volumi “Lavoro e contratti nel pubblico impiego”. Dal 1996 al 2006 è stato responsabile del periodico di informazione e cultura sindacale “Il Corriere del Lavoro”.



Seguiteci su Facebook