Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona
Anno XIII - n° 67
Gennaio/Febbraio 2025
La disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese in liquidazione
Tra sospensione e continuità giuridica dei dipendenti dell’impresa soggetta a liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter
di Ida Giannetti [*]

L’articolo si propone di approfondire le modifiche ed integrazioni che il legislatore con il D. lgs. 136/2024 (cd. correttivo-ter), utilizzando la tecnica della cd. novellazione ha apportato all’originaria disciplina della gestione dei rapporti di lavoro in costanza di liquidazione giudiziale, non essendo state operate modifiche incidenti sui profili lavoristici delle altre procedure disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Considerazioni preliminari
 Il Codice della crisi e dell’insolvenza
[1] ha considerato, a fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, nella liquidazione giudiziale
[2] oltre che nel concordato preventivo
[3] soluzioni finalizzate a realizzare la salvaguardia e la conservazione del patrimonio aziendale, sicché senza pregiudicare gli interessi dei creditori si è cercato di salvaguardare anche i livelli occupazionali. Ed invero, coerentemente, si è ritenuto in una prima stesura del Codice della Crisi, di utilizzare le misure di allerta
[4], come strumento per favorire l’emersione tempestiva della crisi, e per evitare che essa possa degenerare in insolvenza e, conseguentemente, privilegiare le proposte di concordato in continuità. Il legislatore della riforma, quindi, è intervenuto apportando alcune modifiche all’istituto dell’esercizio provvisorio allo scopo di incentivare la prosecuzione dell’attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale. Difatti, viene enunciato al primo comma dell’art. 211 che l’apertura della liquidazione giudiziale …non determina la cessazione dell’attività di impresa, … purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”
[5]. Tale valutazione è rimessa allo stesso Tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la fase concorsuale, ovvero, successivamente, al Giudice Delegato, con il parere favorevole del Comitato dei creditori che viene convocato ogni tre mesi, dal curatore a pronunciarsi sulla opportunità della prosecuzione[6].
Il Codice della crisi e dell’insolvenza
[1] ha considerato, a fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, nella liquidazione giudiziale
[2] oltre che nel concordato preventivo
[3] soluzioni finalizzate a realizzare la salvaguardia e la conservazione del patrimonio aziendale, sicché senza pregiudicare gli interessi dei creditori si è cercato di salvaguardare anche i livelli occupazionali. Ed invero, coerentemente, si è ritenuto in una prima stesura del Codice della Crisi, di utilizzare le misure di allerta
[4], come strumento per favorire l’emersione tempestiva della crisi, e per evitare che essa possa degenerare in insolvenza e, conseguentemente, privilegiare le proposte di concordato in continuità. Il legislatore della riforma, quindi, è intervenuto apportando alcune modifiche all’istituto dell’esercizio provvisorio allo scopo di incentivare la prosecuzione dell’attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale. Difatti, viene enunciato al primo comma dell’art. 211 che l’apertura della liquidazione giudiziale …non determina la cessazione dell’attività di impresa, … purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”
[5]. Tale valutazione è rimessa allo stesso Tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la fase concorsuale, ovvero, successivamente, al Giudice Delegato, con il parere favorevole del Comitato dei creditori che viene convocato ogni tre mesi, dal curatore a pronunciarsi sulla opportunità della prosecuzione[6].
La stessa soluzione è stata adottata poi, per i contratti pendenti, infatti, è previsto al comma 8° del medesimo articolo, che essi proseguano “…salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli”. Si noti che essendo stato espunto il requisito del “grave danno”, richiesto dalla precedente formulazione dell’art. 211 al co.1, perché fosse disposto l’esercizio provvisorio, nella nuova formulazione, la prosecuzione rimarrebbe ancorata al fine del mantenimento dei livelli occupazionali sempreché la stessa “non arrechi pregiudizio ai creditori”.
Essa, altresì, è diretta ad assicurare la migliore realizzazione dell’attivo, essendo la continuazione, espressione dei valori insiti nell’impresa. Con l’esercizio provvisorio dell’impresa, il curatore si sostituisce all’imprenditore insolvente nella gestione, nel senso che subentra nell’amministrazione di tutto il patrimonio, assumendone diritti ed obblighi per i fatti e le obbligazioni posteriori all’apertura del concorso, in quanto viene a svolgere un’attività di gestione amministrativa di tutto il patrimonio. La prosecuzione dell’attività deve essere congegnata al fine di giovare alla massa dei creditori concorrenti e per quanto possibile alla tutela degli interessi sociali, rappresentati dalla stabilità e dalla prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’impresa.
La regolamentazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza consegue sia alla attuazione di principi generali contenuti nell’art.2, c.1, lett. p) legge-delega n.155 del 2017, laddove si annovera tra gli obiettivi della riforma quello di «armonizzare le procedure di gestione della crisi dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo [7] e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 [8] , come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea»; sia del principio più specifico, di rilevanza lavoristica e contemplato nell’ambito della liquidazione giudiziale, enunciato all’art. 7, comma 7° della legge delega prevedendo che: «la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato fosse coordinata con la legislazione in materia di diritto del lavoro per quanto concerne il licenziamento, il trattamento di fine rapporto, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo».
Il mantenimento delle tutele previste dal diritto del lavoro e dei diritti dei lavoratori, con specifico riferimento all’ipotesi in cui il piano di ristrutturazione comporti il trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento, è pure previsto dal 34° e 35° Considerando della proposta di direttiva della Commissione Ue riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda chance e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, a modifica della Direttiva 2012/30 UE[9].
Uno sguardo al passato: le lacune della legge fallimentare nella disciplina dei contratti di lavoro
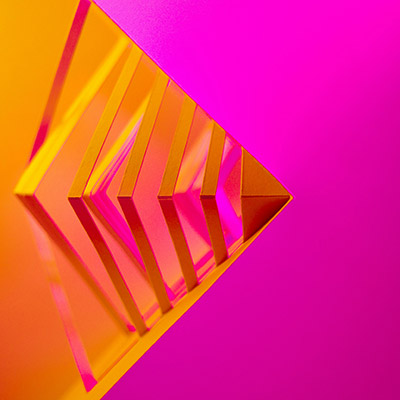 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina, finalmente, nell’ambito del diritto concorsuale, la sorte dei rapporti di lavoro pendenti. È questa una novità, poiché la disciplina previgente risalente alla legge fallimentare, non regolamentava espressamente il contratto di lavoro, si limitava con l’art. 72, rubricato “rapporti pendenti” a dettare una disciplina omnicomprensiva per i contratti pendenti, generando contrapposti orientamenti in dottrina e in giurisprudenza circa l’applicabilità o meno della disciplina ivi contenuta, anche ai rapporti di lavoro.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina, finalmente, nell’ambito del diritto concorsuale, la sorte dei rapporti di lavoro pendenti. È questa una novità, poiché la disciplina previgente risalente alla legge fallimentare, non regolamentava espressamente il contratto di lavoro, si limitava con l’art. 72, rubricato “rapporti pendenti” a dettare una disciplina omnicomprensiva per i contratti pendenti, generando contrapposti orientamenti in dottrina e in giurisprudenza circa l’applicabilità o meno della disciplina ivi contenuta, anche ai rapporti di lavoro.
Propendeva per l’estensione della disciplina anche ai rapporti di lavoro pendenti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, chi aderiva alla tesi[10], a dir vero maggioritaria, della portata generale della norma, con la conseguenza che i rapporti di lavoro rimanevano sospesi fino alla decisione del curatore. A tale orientamento, si contrapponeva quello che, rinveniva la regola di relazione dei rapporti di lavoro con le procedure concorsuali, al di fuori del r. d. 267/1942 e cioè nella norma codicistica, l’art. 2119 c.c. che, facendo leva sull’assunto che “il fallimento non costituisse giusta causa di recesso”, asseriva che i rapporti di lavoro proseguissero automaticamente, salvo poi la possibilità per il curatore di recedere secondo le regole di diritto del lavoro.
Appare evidente che, per quest’ultimo orientamento, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato pendenti, si rinveniva al di fuori della legge fallimentare che, viceversa, li richiamava all’art. 169-bis, co. 4, l. fall., soltanto ad excludenda, cioè per ribadire l’inapplicabilità ad essi delle disposizioni in materia di contratti pendenti nel concordato preventivo. Anche il legislatore della riforma della legge fallimentare, attuata con il d.lgs. n. 5 del 2006, ha preferito non dettare norme ad hoc per il contratto di lavoro, dimenticando, forse le ricadute che, a dir poco gravi, il fenomeno della crisi irreversibile, può comportare sulla sorte dei rapporti di lavoro ancora in corso.
Lo stato dell’arte, a legislazione intermedia e cioè prima dell’entrata in vigore del CCII e in particolare, quello del correttivo-ter, potrebbe riassumersi nella vigenza della disposizione codicistica di cui all’art. 2119, co. 2 cod. civ., che nel disporre che il fallimento non è giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, andrebbe coordinata con il sistema ideato dalla legge fallimentare che non fa discendere da esso la disgregazione dell’attività aziendale né l’impossibilità della prosecuzione dell’attività, sempreché venga autorizzato l’esercizio provvisorio dal tribunale; l’art. 72 l. f. riconosceva alla curatela, autorizzata dal comitato dei creditori, la possibilità di subentrare nei contratti pendenti.
Il legislatore del correttivo-ter, muovendosi in uno scenario già cambiato con l’entrata in vigore del CCII, si mostra più sensibile alla tutela e al mantenimento dei livelli occupazionali, ha esplicitamente disciplinato i rapporti di lavoro pendenti, con ciò aderendo ad una concezione di azienda che staccandosi da quella prettamente codicistica[11], valorizza l’organizzazione intesa non soltanto con riferimento ai beni strumentali, ma soprattutto alle risorse umane, ai lavoratori ed in particolare, a quelle professionalità che rappresentano nello scenario aziendale, quel quid pluris, in grado di assicurare una maggiore realizzazione dell’attivo, sempreché mantengano lo status di lavoratori occupati.
Ora, come allora, è giustificata la non corresponsione della retribuzione al lavoratore, rimanendo i rapporti di lavoro in essere, ope legis, sospesi temporaneamente e cioè fino a quando il curatore decide di volervi subentrare. Ciò discende dalla natura sinallagmatica delle corrispondenti obbligazioni tra lavoratore e datore di lavoro all’interno del contratto individuale di lavoro; è in re ipsa che il credito del lavoratore cioè quello ad ottenere la retribuzione, sia pure mensile, non matura poiché il lavoratore, anche se per fatti indipendenti dalla sua volontà non può rendere la prestazione lavorativa. Si potrebbe ipotizzare, un caso di impossibilità sopravvenuta di durata indeterminata da parte del curatore di ricevere la prestazione del lavoratore[12].
Le modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato nel correttivo -ter
Sul piano lavoristico sono di particolare rilievo gli articoli 189 e 190 del CCII che disciplinano nel dettaglio gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato e lo fanno in un’ottica di armonizzazione, prefigurata dal legislatore comunitario, delle procedure concorsuali con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori. Il legislatore italiano, infatti, con l’art. 32 del D. Lgs. 136/2024, ha apportato modifiche al Titolo V, Capo I, sezione V, della Parte Prima del D. Lgs. 14/2019 incidendo, quindi, significativamente sulla formulazione originaria dell’art. 189 del CCII, rubricato appunto “Rapporti di lavoro subordinato”.
 In primis, ha sentito la necessità di eliminare il primo periodo al comma 1 dell’art. 189 laddove si affermava che “l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento”
[13]. Rimane invariato, invece, il periodo successivo che conferma la sospensione del rapporto sino a quando il curatore, sentito il Comitato dei creditori, con l’autorizzazione del giudice delegato, non decide se subentrare, assumendo i relativi obblighi, ovvero recedere, ai sensi della disciplina lavoristica.
In primis, ha sentito la necessità di eliminare il primo periodo al comma 1 dell’art. 189 laddove si affermava che “l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento”
[13]. Rimane invariato, invece, il periodo successivo che conferma la sospensione del rapporto sino a quando il curatore, sentito il Comitato dei creditori, con l’autorizzazione del giudice delegato, non decide se subentrare, assumendo i relativi obblighi, ovvero recedere, ai sensi della disciplina lavoristica.
La ratio di questa modifica è da rinvenire evidentemente nell’adozione di una tecnica legislativa semplificata, con eliminazione di quelle espressioni che sono apparse nella pratica superflue[14]. Del resto, il nuovo testo dell’art.2119 c.c., a cui il primo comma dell’art.189 CCII echeggiava, si limita ad un rinvio alle norme del CCII, senza aggiungere alcunché. La norma prevede, altresì, che il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinati sospesi, ha come dies a quo, “la data di apertura della liquidazione giudiziale” e quindi ha effetto retroattivo; laddove il subentro decorre dalla comunicazione del medesimo effettuata ai lavoratori.
Una delle novità del correttivo -ter, è stata senz’altro l’eliminazione del secondo periodo del comma 2° dell’art. 189, con il quale era posto a carico del curatore l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, ove cioè si era aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l’elenco dei dipendenti dell’impresa in forza al momento dell’apertura. Qualora l’impresa occupasse più di 50 dipendenti, era prevista una proroga da parte del Giudice Delegato, su richiesta del curatore di ulteriori trenta giorni.
Evidentemente, la previsione, riconosceva un potere di rinegoziazione al Capo dell’Ispettorato in alternativa al curatore. Non si ritiene di condividere l’opinione, pur presente in dottrina, che si è trattato “dell’eliminazione di un adempimento formale rivelatosi di scarsissima utilità” [15] perché così ragionando si ridimensiona il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni territoriali, quale agenzia pubblica italiana che è preposta alla vigilanza in materia di lavoro e della previdenza sociale. In tale sua qualità, l’INL, che comprende anche il personale di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL, tutela i lavoratori dallo sfruttamento e lavoro sommerso assicurando il rispetto delle norme previste per le relazioni lavorative, coordinandosi con altri organi di vigilanza come ad es. con i servizi ispettivi delle ASL.
Per il resto, la norma anche dopo le modifiche, conferma che non scatta alcun automatismo nei rapporti di lavoro una volta aperta la procedura di liquidazione giudiziale. È contemplata nel 3° comma dell’articolo in commento anche l’ipotesi della impossibilità della continuazione o del trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, in tal caso è imposto al curatore di comunicare il recesso dei relativi rapporti mediante atto scritto[16].
Traspare dal 3° comma dell’art. 189 CCII, una sorta di attenuazione della responsabilità del curatore che invece di procedere “senza indugio” (come nella precedente formulazione della norma), si limiti a comunicare per iscritto il recesso dal rapporto di lavoro solo laddove non sia disposta, né autorizzata, la prosecuzione dell’esercizio di impresa, rimettendo all’esclusiva valutazione del giudice la scelta di mantenere in vita i rapporti di lavoro pendenti.
Da una lettura del comma 2 dell’art. 189 come anche da quella del comma 3 sembra che il legislatore abbia ritenuto giustificato il recesso del curatore dai rapporti di lavoro tutte le volte che vi siano “manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro” tali da non rendere possibile la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa né possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o di una qualsiasi vicenda circolatoria come ad es. la cessione indiretta. Ciò significa che non può trattarsi di recesso acausale ma che trova una sua ratio nel giustificato motivo oggettivo richiamato dalla norma in commento e che, si coniuga bene sia con quanto previsto dalle direttive comunitarie sia dalla previsione nel comma 6, lett. c), dell’art. 189 CCII laddove[17] risulta che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro non può sollecitare l’esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali e unitarie circa i motivi che hanno portato ad un licenziamento collettivo, qualora la procedura sia stata determinata dalla “cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo”.
Rimane, invece, anche nella nuova stesura della norma, l’obbligo per il curatore, che intenda avviare la procedura di licenziamento collettivo, di dare comunicazione per iscritto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente nei territori in cui i dipendenti prestino la propria attività, in maniera prevalente nonché nel luogo ove si è aperta la procedura di liquidazione giudiziale[18]. È, altresì, consentito al lavoratore di rassegnare le dimissioni, “trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione”.
A prevedere questa facoltà è il comma 5 del medesimo articolo 189 CCII che aggiunge che “…esse si intendono rassegnate per giusta causa” ai sensi dell’art. 2119 c.c. Anche se si tratta di un lasso di tempo non breve, nulla vieta al lavoratore di rassegnare le dimissioni prima del termine ivi previsto, senza poter aver diritto all’indennità di mancato preavviso, né poter beneficiare del diritto alla NASPI dal momento che la stessa si percepisce solo in caso di involontaria perdita del posto di lavoro. Invero, i rapporti di lavoro rimangono sospesi, per un periodo che, di regola, può durare sino a quattro mesi, salvo diversa decisione del curatore. Quest’ultimo, infatti, può chiedere al giudice delegato una proroga di ulteriori quattro mesi[19] nel caso in cui sussistano elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo e, pertanto, il giudice delegato ritenga vi siano indicatori oggettivi per la prosecuzione dell’attività.
La sospensione apre per così dire una parentesi, i lavoratori non prestano alcun servizio attivo né maturano diritti retributivi e/o contributivi. Invero, l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 189 CCII, dispone che nel caso di “cessazione dei rapporti di lavoro, …non è dovuta dal lavoratore, la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione.”
In verità, meno evidente è questa volta l’intento chiarificatore del legislatore poiché l’art. 190 CCII rubricato appunto “Trattamento NASpI”, non prevede che durante il periodo di sospensione i lavoratori possano beneficiare del suddetto trattamento che trova il suo presupposto nella perdita involontaria del posto di lavoro; conseguentemente non si capisce che cosa avrebbero dovuto restituire i lavoratori. Ne consegue che il richiamo nella stesura riformata della norma sembra superfluo. Il comma 4 dell’art. 189 nella sua versione post-correttivo, poi, elimina altra tutela prevista per i lavoratori in caso di proroga. Infatti, la versione attuale non prevede più il sostegno pari ad una indennità corrispondente ad almeno due mensilità fino ad un massimo di otto, utili per la valutazione del TFR. La norma post correttivo, non solo toglie questa indispensabile garanzia per i lavoratori durante la vacatio ma non la sostituisce con alcuna misura alternativa, modifica a dir poco discutibile in uno Stato, che, come l’Italia, è etichettato uno “Stato sociale di diritto”!
Il Trattamento NASpI
 Riguardo alle misure di sostegno al reddito, l’art. 190 del CCII è rimasto sostanzialmente immutato nel 1°comma, laddove, poi, il correttivo-ter aggiunge il co.1-bis concernente il dies a quo per la presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Ebbene, nell’ottica del Legislatore del Codice della Crisi in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tra dipendente e società in fase di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 189 CCII, tale evento è da qualificarsi “perdita involontaria dell’occupazione” e va equiparata a quelle circostanze che richiedono l’applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 22/2015. Conseguentemente, al lavoratore è riconosciuto la cd. “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI); la norma, quindi, fuga ogni dubbio in ordine all’applicazione del trattamento previsto per dipendenti in stato di disoccupazione anche per tali lavoratori.
Riguardo alle misure di sostegno al reddito, l’art. 190 del CCII è rimasto sostanzialmente immutato nel 1°comma, laddove, poi, il correttivo-ter aggiunge il co.1-bis concernente il dies a quo per la presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Ebbene, nell’ottica del Legislatore del Codice della Crisi in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tra dipendente e società in fase di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 189 CCII, tale evento è da qualificarsi “perdita involontaria dell’occupazione” e va equiparata a quelle circostanze che richiedono l’applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 22/2015. Conseguentemente, al lavoratore è riconosciuto la cd. “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI); la norma, quindi, fuga ogni dubbio in ordine all’applicazione del trattamento previsto per dipendenti in stato di disoccupazione anche per tali lavoratori.
Conclusioni e prospettive future
Il nuovo correttivo -ter ha introdotto significative modifiche nella gestione dei rapporti di lavoro durante la liquidazione giudiziale, ponendo in evidenza la difficile ma cruciale linea di demarcazione tra la continuità e la cessazione dell’attività lavorativa, come rimedio estremo quando cioè una ripresa dell’attività sia pure mediante il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, non sia possibile. Da un lato, la continuità dei contratti di lavoro deve essere preservata al fine di mantenere una certa stabilità nell'impresa e favorire una gestione più ordinata della liquidazione, con salvaguardia dei livelli occupazionali. Dall’altro, laddove la continuazione non sia possibile, la cessazione dell’attività, come epilogo della procedura liquidatoria, appare inevitabile.
Nel complesso, la regolamentazione della sorte dei rapporti di lavoro pendenti nella liquidazione giudiziale deve essere vista come un passo verso una maggiore equità e una gestione più razionale delle situazioni di crisi aziendale, ma sarà fondamentale monitorare l’efficacia di queste disposizioni nel garantire sia la continuità produttiva che la giusta tutela per i lavoratori coinvolti. Il futuro dell'applicazione del correttivo dipenderà, in ultima analisi, dalla capacità di armonizzare le procedure concorsuali con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.
Rassegna Scientifica
 Caiafa A., (2024), Commentario al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, Dike Editore.
Caiafa A., (2024), Commentario al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, Dike Editore.
Corrado A. – Corrado D., (2024), “La (poco coraggiosa) revisione dell’art. 189 CCII ad opera del correttivo-ter”, in IUS, Crisi d’impresa, Giuffrè Francis Lefebvre.
Cristallini E., (2021), “Liquidazione giudiziale e sorte dei rapporti di lavoro”, in Diritto e Pratica del lavoro n.16.
Ghezzi G., (1965), “La mora del creditore”, Milano, Giuffrè editore.
Imberti L., (2022), “Tutela dei creditori e tutela dei lavoratori nel Codice della Crisi d’Impresa” in Rivista nuova di Diritto del Lavoro, Lavoro Diritti Europa.
Ioverno F., (2025), “OCC: trattamento dei rapporti di lavoro nelle procedure di sovraindebitamento” in IUS, Crisi d’impresa, Giuffrè Francis Lefebvre.
Lamanna F., (2025), “Il terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Giuffrè Francis Lefebvre.
Panzani L., (2017) “La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance”, in Fallimento, n. 2.
Patti A., (2022), “Rapporti di lavoro e impresa in crisi”, in Rivista Questione Giustizia, fascicolo 2-3.
Ponari C., (2025), “La disciplina della cessazione del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale: le modifiche apportate dal Correttivo -ter”
Proia G., (2019), “La disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro”, in Mass. Giur. Lav.
Riva A. (2024), “Il punto, in breve, sulla gestione dei rapporti di lavoro pendenti sulla liquidazione giudiziale”, in IUS, Crisi d’impresa, Giuffrè Francis Lefebvre.
Sanzo S. e Burroni D., (2024), “Il nuovo Codice della crisi dopo il correttivo ter”, Zanichelli Editore.
Note
[1] A differenza del R.D. 267/1942 è un vero e proprio codice e non una legge.
[2] Trattasi di un procedimento di esecuzione diretto al soddisfacimento dei creditori attraverso la espropriazione di tutti i beni del debitore ma anche in tale fase non è estranea la finalità di conservazione dell’azienda o di un ramo di essa.
[3] Anche sul concordato preventivo in continuità, il legislatore del correttivo-ter è intervenuto all’art. 84 commi 2 e 3 CCII.
[4] È noto che l’intero Titolo II concernente le” Procedure di allerta e di composizione della crisi” e conseguentemente, il Capo I, rubricato “Strumenti di Allerta” è stato sostituito con il capo “Composizione negoziata della crisi” ad opera dell’art.6, comma 1, del D. Lgs.17 giugno 2022, n. 83.
[5] Il testo precedente del 2° comma dell’art. 211 CCII, è stato modificato dall’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e disponeva che “…se dall’interruzione può derivare un grave danno”.
[6] È quella, per il curatore, anche l’occasione per essere informato sull’andamento della gestione.
[7] Trattasi della Direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
[8] Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti, o di parti di imprese o di stabilimenti.
[9] Trattasi della “Directive of the european parliament and of the council on preventive restructuring frameworks, second and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU-COM/2016/0723 final.” Per un primo commento sulla proposta di Direttiva che segue la Raccomandazione del 14 marzo 2014, cfr. Panzani L., (2017) “La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance”, in Fallimento, n. 2, pag. 219 e ss.
[10] Tale tesi sposata da Grassetti, (1974), “Fallimento e rapporto di lavoro”, in Giur. Comm., 1974; Ferrara F. e Borgioli, (1995), “Il fallimento”, Milano, 1995 era, del resto, condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. 5 febbraio 1980, n. 799, in Foro it., 1980, I, 2558; Cas. sent. n. 522/2018; Tribunale di Napoli, 10 febbraio 1994, in Fall, 1994, 774.
[11] Il riferimento è naturalmente alla nozione di azienda di cui all’art.2555 c.c. come “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
[12] Nel senso che si potrebbe parlare di “mora del creditore” si è espresso in dottrina il Ghezzi G., (1965) “La mora del creditore”, Milano, Giuffrè editore.
[13] A ben vedere, l’espressione iniziale riecheggia il disposto dell’art. 2119, 2° co. c.c. nella precedente formulazione secondo il quale “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa”.
[14] V. in dottrina Lucio Imberti, 2024, “Il terzo atto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa: dal d.lgs. n. 136/2024 alcuni opportuni chiarimenti sui rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale” in Lavoro Diritti Europa, Rivista Nuova di Diritto del Lavoro, www.lavorodirittieuropa.it .
[15] In tal senso cfr. Lucio Imberti, 2024, op. cit. Contra, Caiafa A., (2024), Commentario al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, voce “Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata” Dike Editore, dove si afferma “…non comprendendosi la ragione di una siffatta previsione, dal momento che non era alla stessa ancorata alcuna attività da parte dell’Ispettorato, se non in ragione della riconosciuta possibilità per questo di chiedere al giudice delegato, qualora avesse ritenuto sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento d’azienda, o di un ramo di questi a terzi, di concedere una proroga”.
[16] È stato notato da autorevole dottrina che “il curatore dovrà utilizzare il tempo concesso dalla nuova normativa al fine di valutare la convenienza, ai fini della produttività aziendale, del mantenimento dei rapporti di lavoro o, in alternativa, della necessità di procedere alla loro cessazione”. In tal senso cfr. Rossetti M., (2025) “Gestione crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Giuffrè Francis Lefebvre.
[17] Dopo le modifiche apportate dal correttivo -ter.
[18] La procedura di licenziamento collettivo disciplinato nel co. 6 dell’art. 189 CCII, non si applica alle grandi imprese poste in stato di amministrazione straordinaria né ai sensi del co. 7 del medesimo articolo, ai casi disciplinati dall’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234/2001 (cd. norme antidelocalizzazioni). Di rilievo è stata una recente ordinanza della Cassazione la n. 35527 del 19.12.23, con la quale, in sintesi, la Suprema Corte, avallando la sentenza di secondo grado dei giudici di merito, circa la nullità del licenziamento irrogato ad una lavoratrice madre (ancora in periodo di congedo obbligatorio di maternità), dal curatore durante l’esistenza di una procedura di liquidazione giudiziale coeva alla prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di crisi.
[19] In totale la sospensione potrebbe avere una durata pari a otto mesi.
[*] Dottoranda di ricerca presso Università Mercatorum di Roma. Cultore della materia in Economia Aziendale presso Università Parthenope di Napoli. Ispettore del Lavoro presso ITL di Napoli. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.




Seguiteci su Facebook